Angelo Casati, un prete nella città
Doppiozero, 26 marzo, 2025
Gabriella Caramore
Un disordine accelerato si presenta alle nostre menti in tutti gli ambiti della vita pubblica. E di conseguenza anche nel nostro privato. Questo primo quarto di secolo, e in particolare gli ultimi anni, ma direi proprio gli ultimi mesi e settimane, ci aggrediscono con segnali confusi che sollecitano una miriade di interpretazioni e di tentativi di comprensione. Ma l’impressione è che ben pochi arrivino a fare chiarezza, ad avere una visione limpida delle cause che hanno prodotto questo caos, a capire quale direzione il mondo dovrebbe prendere, per uscire dal tragico trambusto nel quale siamo precipitati.
Parole di segno opposto – pace, guerra; democrazia, tirannide; genocidio, giustizia per tutti i popoli – sembrano diventate interscambiabili, a seconda della prospettiva da cui si mettono a fuoco i drammi che si svolgono sulla scena della storia. Così tutti si accapigliano con tutti. E rare sono le parole che hanno un sentore di verità.
Angelo Casati, un prete nella città
Un disordine accelerato si presenta alle nostre menti in tutti gli ambiti della vita pubblica. E di conseguenza anche nel nostro privato. Questo primo quarto di secolo, e in particolare gli ultimi anni, ma direi proprio gli ultimi mesi e settimane, ci aggrediscono con segnali confusi che sollecitano una miriade di interpretazioni e di tentativi di comprensione. Ma l’impressione è che ben pochi arrivino a fare chiarezza, ad avere una visione limpida delle cause che hanno prodotto questo caos, a capire quale direzione il mondo dovrebbe prendere, per uscire dal tragico trambusto nel quale siamo precipitati.
Parole di segno opposto – pace, guerra; democrazia, tirannide; genocidio, giustizia per tutti i popoli – sembrano diventate interscambiabili, a seconda della prospettiva da cui si mettono a fuoco i drammi che si svolgono sulla scena della storia. Così tutti si accapigliano con tutti. E rare sono le parole che hanno un sentore di verità.
Anche la geografia delle fedi ne rimane sconvolta. Inevitabilmente. Sembra contaminata da una nuova Babele. Anche a guardare soltanto al cristianesimo ne emergono le istanze più diverse. A fronte di un tradizionalismo soprattutto in campo etico nei paesi dei continenti africano, asiatico, latinoamericano, che si sposano in maniera fantasiosa con antiche tradizioni locali, nel mondo cosiddetto occidentale si va da istanze di severo conservatorismo (c’è chi dice, appunto, che papa Francesco è un falso papa, perché non combacia perfettamente con i dettami della tradizione); all’esasperazione nazionalista del versante ortodosso, accentuata negli ultimi tre anni dalla crisi russo-ucraina; alla deriva ideologica di alcune chiese cosiddette evangelicali, fino ad arrivare a quella tragicomica (ma più tragica che comica) pantomima della “religione della prosperità” di cui si fa profeta lo stesso Trump, salvato da Dio, per salvare l’America e dunque il mondo, il cui verbo è diffuso dalla portavoce dell’ufficio della fede alla Casa Bianca, Paula White.
All’interno del cattolicesimo il declino fisico di Francesco lascia aperte molte incognite in una chiesa che, nonostante la popolarità di questo papa riempia le piazze, sta vivendo una emorragia di fedeli in tutte le fasce di età: i bambini che trovano altrove nutrimento ai loro interessi; gli anziani – che una volta erano la riserva aurea del popolo dei fedeli – oggi sono più interessati a ricevere aiuti e stimoli piuttosto che prospettive spirituali; per non parlare delle donne, che, stanche di essere messe ai margini dalle gerarchie, sempre più trovano spazi alternativi per nutrire la loro mente e il loro spirito. La formazione dei giovani presbiteri vede, nei seminari, tranne qualche eccezione, una tendenza a un conservatorismo arcaico, come se si potesse con ciò porre riparo alla deriva di senso che la fede inevitabilmente incontra nell’era della complessità.
Tuttavia a guardare in maniera più ravvicinata il fantasmagorico mosaico delle fedi, si incontrano figure – ovunque – nelle quali è possibile ravvisare ancora il senso di una “appartenenza”, senza che esso strida con le esigenze della contemporaneità e senza che vi sia conflitto con le persone che – ovunque, di nuovo, ma in contesti non religiosi – cercano di operare con giustizia, con una creatività non distruttiva, con passione di conoscenza, con amore gentile e generoso nei confronti di tutto ciò che vive su questa terra.
Alcune di queste figure – non ne ho conosciute poche, negli anni – mi sono particolarmente care. Trovo in esse una coerenza non formale, una “rettitudine” di fondo, sulla quale so di poter fare affidamento. Tra queste, un anziano prete – guai a chiamarlo “sacerdote”! – che vive, ora che è in pensione, in una casa parrocchiale a Milano, nel cuore delle strade del lusso, della moda, della ricchezza esibita e sfrontata. Senza farsi minimamente scalfire da quel contesto così in contrasto con la sua semplicità di vita, predica tutte le domeniche, nonostante l’età e le fatiche di un corpo gracile e consumato. Per questo ogni volta che vado a Milano mi ricavo una piccola porzione di tempo per andarlo a trovare.
Angelo Casati è prete – “presbitero” sarebbe più corretto – si può dire da sempre. Entrato presto in Seminario, ha esercitato il ministero a Busto Arsizio e a Lecco, poi è stato chiamato a Milano dal cardinal Martini, a fare il parroco a San Giovanni in Laterano. Ben presto la sua disponibilità nei confronti del prossimo, la chiarezza e la lucidità con cui ha affrontato le asprezze delle Scritture, la sua capacità di rapportarle senza forzature al travaglio e alle sofferenze in cui versa questo nostro tempo gli hanno conquistato una solida e unanime fama di uomo giusto e mite, un docile guerriero che combatte senza ferire, ma per rivendicare con umiltà serena e ferma l’esigenza di essere dalla parte dei deboli, degli sfruttati, degli umiliati. Denunciando senza remore e senza reticenze, ma anche senza spietatezze inutili, i raggiri e le atrocità dei potenti. Svelando con ciò il significato profondo, talvolta nascosto, di ogni parola contenuta nei testi “sacri”. Senza feticismi: se alcune parole o versetti della Bibbia sono oggi indifendibili e improponibili li lascia cadere: non arbitrariamente, ma riconsegnandoli al tempo in cui sono nati. Si concentra, con libertà e con acume, su tutto ciò da cui le nostre povere vite possono trarre linfa e sostegno. Abituato a sostare sulle parole, essendo egli stesso poeta, si serve di questo suo “mestiere” per sondare in profondità la gamma espressiva del linguaggio biblico. Sapendo però, allo stesso tempo, che le parole della fede, così come le parole della poesia, non arrivano mai a circoscrivere una verità. Vi si possono solo approssimare, lasciando sempre libero uno spazio per ulteriori esplorazioni.
L’ho conosciuto molti anni fa – direi una trentina – in un ambiente di incontri ecumenici e interreligiosi. Mi aveva colpito anche allora la misura del suo parlare, il desiderio di confrontarsi con altri, anche per vincere la solitudine della vita di prete, che non nascondeva dietro disinvolture di facciata. Il suo sguardo, affaticato dalle letture, ma reso vigile dalle ampiezze del cuore, già allora ti guardava senza scrutare troppo, semplicemente accogliendo. Negli anni, ho potuto leggere moltissime cose uscite dalla sua penna. Non perché lui abbia cercato il prestigio della pubblicazione. I suoi sono tutti libri nati dal desiderio di qualcuno che lo ha ascoltato, e non ha voluto permettere che le sue parole andassero disperse nell’aria magari distratta e sonnolenta di una navata di chiesa (anche se, per la verità, chi lo segue fa sempre tesoro prezioso di ciò che dice la sua esile voce).
Particolarmente cara mi è questa ultima piccola raccolta, Sconfinamenti, edita da Qiqajon, della Comunità di Bose, fondata da Enzo Bianchi. Come scrive il priore Sabino Chialà, nella sua prefazione, la sua è una “parola dolce e forte, mite e tagliente”. Si potrebbe aggiungere: severa ma non malevola, colta ma non erudita. Ma il tema del confine e dello sconfinare è da sempre uno dei preferiti di don Angelo. Anche il suo stesso linguaggio – “procedo in modo rapsodico, vado per trasalimenti” – indica il suo appartenere a questo tempo, alla nostra storia, alla città in cui vive. Ma nello stesso tempo gli è necessario sconfinare verso luoghi altri, verso un “oltre” rispetto alla pura quotidianità dell’esistente, che però non indugia nelle forzate immagini della dottrina, ma scavalca i fili spinati delle convenzioni, e si apre a inediti orizzonti.
“Occorre camminare – scrive – per le strade delle nostre città, custodendo l’arte di interrogare i cieli, di interrogare la terra, di interrogare la vita”. A girare per le strade delle nostre città si è colti da una specie di spaesamento. Troppa velocità, e violenza, e indifferenza. Ma non bisogna farsene schiacciare. Occorre saper scovare anche quel “sommerso di bene che non appare. Un sommerso di bene, di sacrificio, di generosità, di fatica quotidiana, di passione di ricerca, di attesa che non appare”. La città, nelle sue parole, è il luogo ideale per vivere un’esperienza spirituale. Non perché non ci sia bisogno anche di “rallentare il passo”, “fare silenzio”, “incantarsi”. Ma perché la vita dello spirito, se così la si può chiamare, è vita di relazione, di critica, di discernimento. “La strada della città, proprio perché terra di pluralismo, è luogo delle domande: quelle serie, quelle della vita, così diverse dalle domande coltivate in laboratorio!”. Le domande delle Scritture hanno una loro ragion d’essere, anche in questo tempo del disincanto e spesso dello scoraggiamento, solo se si intrecciano con le domande della vita, di quella vera, dura e fragile, spietata e tenerissima.
Anche questo è uno sconfinare: il fluente – non sempre indolore – trasmigrare tra le parole delle sapienze e quelle della vita. Occorre “fare racconto”. Costruire “piazze del racconto”. La piazza è il luogo degli incontri variopinti, plurali, talvolta anche conflittuali, oppure in cui si ritrova comunanza di ideali, speranze sopite, costruzioni di socialità. È nella piazza che ci si confronta, che si trovano, eventualmente, anche soluzioni. In fondo, questo dovrebbero essere le chiese: assemblee di comunità dove il centro si mescola alle periferie, i giovani con gli anziani, i più ricchi con i più poveri, i più semplici con i più sapienti. “Miracolo non è rinchiudersi e separarsi nelle diversità, nelle corporazioni; miracolo è formare il popolo delle diversità”.
Ma come nelle vite c’è un tempo per ogni cosa, così anche nelle piazze c’è uno spazio per la moltitudine e uno per le panchine. Le panchine sono il luogo di un incontrarsi più casuale, in cui si scambiano poche parole, in cui senza timore si può confidare qualche verità, si può tacere senza imbarazzo, riprendere a parlare senza preoccuparsi della forma e della coerenza del discorso. Si possono costruire amicizie senza obblighi, affidandosi alla casualità, o alla segreta tessitura della vita. Quando si va da don Angelo, ti riceve nel suo studio. Ti offre ospitalità affettuosa su un divanetto che lui chiama la “panchina”. Lui sta di fronte, seduto su un’altra piccola panchina, in modo che ci si possa guardare negli occhi. E lì pazientemente ascolta le tue storie, e generosamente ti offre le sue, facendo sì che si intreccino, fino a comporre una nuova realtà per entrambi. “Il racconto non è mai nel vociare, va negli occhi”.
Ecco, mi piace pensare che le comunità di fede possano essere anche questo, nel mondo che vorticosamente sta cambiando: costruire, mattone su mattone, racconto su racconto, parola su parola, esitazione su esitazione, piccoli spazi comunicanti
“in cui l’audacia di fare cose nuove
sarà più forte dell’abitudine di fare
come prima
….
in cui ognuno potrà pregare nella sua lingua,
esprimersi nella sua cultura,
ed esistere con la propria storia”.

La fratellanza di Enzo Bianchi
Doppiozero, 12 novembre, 2024
Gabriella Caramore
Lo sappiamo. Ci sono parole diventate afone, come svuotate. Senza una accurata contestualizzazione del loro significato, senza una ridefinizione del loro uso e della loro portata non ne avvertiamo più né il suono né il senso. Spesso sono parole di cui ha abusato il linguaggio religioso, fino a renderle stanche nell’espressione ed esauste nella ricezione. Tra queste c’è anche “fraternità”, lemma dentro il quale coabita una congerie di relazioni e di sentimenti a cui il nostro mondo, per la gran parte, resta sordo e indifferente, nonostante da molte parti si affannino numerosi i tentativi di rianimarlo.
Uno dei meriti del libro di Enzo Bianchi, Fraternità (Einaudi 2024, con una bella pagina introduttiva di Papa Francesco), è proprio quello di provare a fare chiarezza nell’ insieme di significati che “fraternità” contempla e nella diversità dei contesti a cui questa parola si è dovuta adattare:
La fratellanza di Enzo Bianchi
Lo sappiamo. Ci sono parole diventate afone, come svuotate. Senza una accurata contestualizzazione del loro significato, senza una ridefinizione del loro uso e della loro portata non ne avvertiamo più né il suono né il senso. Spesso sono parole di cui ha abusato il linguaggio religioso, fino a renderle stanche nell’espressione ed esauste nella ricezione. Tra queste c’è anche “fraternità”, lemma dentro il quale coabita una congerie di relazioni e di sentimenti a cui il nostro mondo, per la gran parte, resta sordo e indifferente, nonostante da molte parti si affannino numerosi i tentativi di rianimarlo.
Uno dei meriti del libro di Enzo Bianchi, Fraternità (Einaudi 2024, con una bella pagina introduttiva di Papa Francesco), è proprio quello di provare a fare chiarezza nell’ insieme di significati che “fraternità” contempla e nella diversità dei contesti a cui questa parola si è dovuta adattare: quello biologico e antropologico, quello biblico e scritturistico, quello delle comunità religiose in cui ha trovato un alveo rassicurante ma anche soffocante, quello, più in generale, della socialità, che oggi si trova ad essere la cartina di tornasole attraverso cui viene vagliata la necessità o il dramma della fraternità.
Enzo Bianchi parla di una “crisi” della fraternità e della sororità nel nostro tempo. E, proprio per questo, c’è una urgenza di “ripensare la fraternità”, come “fondamento e ragione per una necessaria fiducia nella bontà del vivere insieme; come solidarietà tra membri di una convivenza ai quali è necessario riscoprire il bene comune; come incessante ricostruzione di ponti” là dove le vie attraverso le quali gli esseri si confrontano e costruiscono insieme sono drammaticamente interrotte. Ma per ripensare tutto questo occorre andare all’origine della complessità dell’essere fratelli e sorelle, uscendo innanzitutto dallo stereotipo per cui fratellanza e sorellanza costituirebbero un idilliaco microcosmo di serenità e armonia. Essere fratelli e sorelle è sì, innanzitutto, un dato biologico che sta a indicare l’essere generati da uno stesso seme e da uno stesso grembo. Ma questo non vuol dire automaticamente il dipanarsi solidale di una prossimità. Certo, fratelli e sorelle possono condividere un caldo humus di memorie, di giocosi intrattenimenti, di più maturi interessi. Ma può accadere invece che divergano ferocemente fino a scagliarsi l’uno contro l’altro nel contendersi il bene assoluto che ciascuno ritiene gli sia stato sottratto. Questo è vero da sempre nei singoli nuclei familiari, e su più vasta scala nel macrocosmo degli appartenenti alla cosiddetta famiglia umana, la cui storia è costellata di controversie, di lotte, di selvagge incomprensioni e inimicizie, come si può constatare nelle piccole comunità delle famiglie e nelle comunità più larghe delle etnie, delle nazioni, degli Stati. Il dato biologico della consanguineità si fa da parte, per così dire, per lasciare spazio a una consanguineità simbolica, che si allarga ben oltre la portata naturale. La fraternità si estende dunque dalla famiglia nucleare a quella culturale e sociale. E anche religiosa.
La religione inventa, per così dire, un nuovo nucleo identitario, che trova sostegno e radicamento con nell’idea di Dio, padre – e talvolta madre – di tutti gli esseri viventi. “Con il sorgere dei monoteismi si è manifestata la convinzione che c’è un solo Dio, un solo Creatore, e di conseguenza tutti gli uomini sono fratelli … C’è una unità del genere umano che deve essere riconosciuta come fraternità”. Bianchi cita il profeta Malachia: “Non è forse uno solo il Padre di tutti noi? Non ci ha creati un unico Dio?” (Ml 2,10). La Bibbia ebraica dà, in un certo senso, per scontata la paternità/maternità di Dio, descrivendola per lo più in forma simbolica o metaforica. Ma è prodiga di racconti che narrano le difficoltà dell’essere fratelli e sorelle: gelosie, invidie, soprusi, aggressività – il superamento dei quali esige un lungo faticoso lavoro nelle relazioni e nella coscienza. Nessun idillio, nessun sentimentalismo zuccheroso nell’essere fratelli e sorelle. Piuttosto, la travagliata necessità di costruire convivenza, di riparare ferite, di edificare la pace.
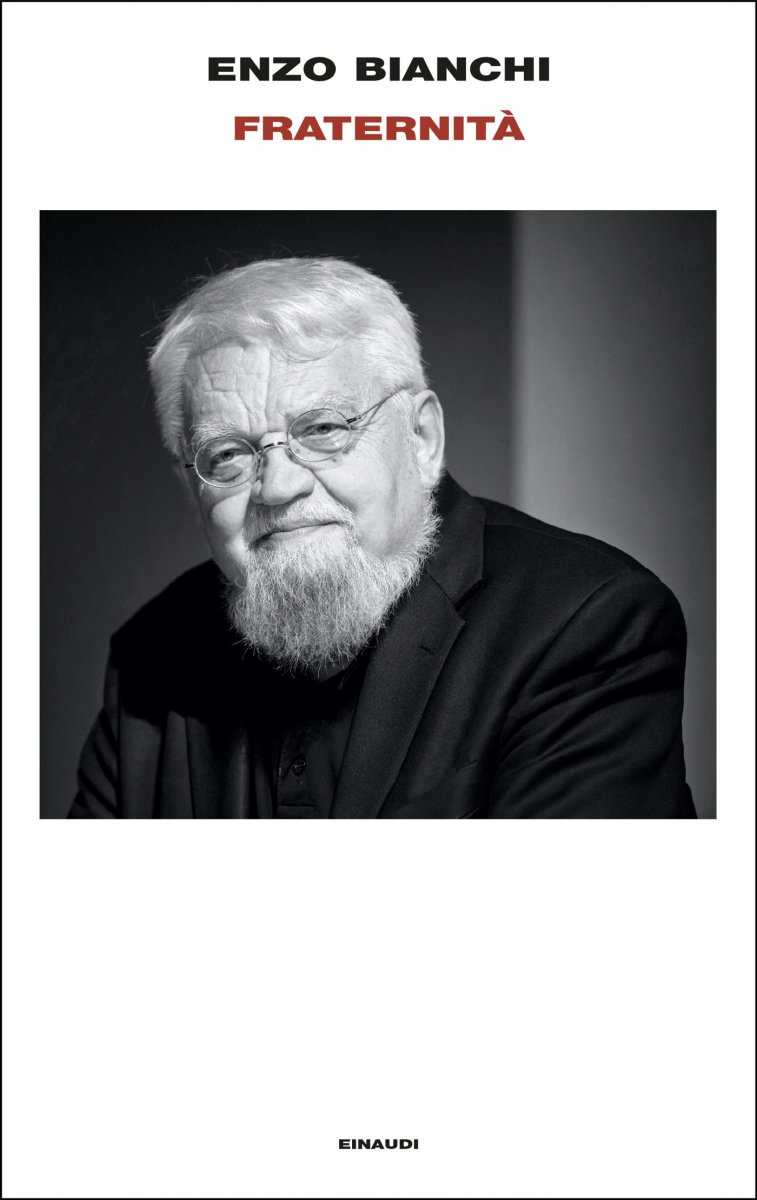
PAOLO RICCA in dialogo infinito
Doppiozero, 10 settembre, 2024
Gabriella Caramore
In una conversazione radiofonica del 2016 (Uomini e Profeti, Radio3), Paolo Ricca, pastore e teologo della chiesa valdese, morto a Roma nella notte fra il 13 e il 14 agosto 2024, affrontava l’oscurità di ogni discorso sulla morte ricorrendo sì alle Scritture e alle acquisizioni della scienza contemporanea, ma assottigliando via via ogni certezza, riconoscendo che ogni cultura ha elaborato “visioni fantastiche” intorno alla morte, senza però accontentarsi di quello che diceva una nota scienziata, secondo la quale ciascuno di noi si ridurrà a una “molecola” vagante nell’universo. Certo, il corpo se ne va. Ma non credo, diceva, che la “persona” possa ridursi a una molecola. È vero che la morte cancella la vita, tuttavia non dissolve la “persona”. Qualcosa rimane. Non solo nella memoria dei vivi, ma in quella che lui chiamava la “memoria di Dio”, e che noi potremmo chiamare una grandezza che ci trascende, un “oltre” in cui non valgono più le categorie “terrene” di spazio e tempo, ma che pure esiste anche se per noi rimane invisibile e inconoscibile. …
Paolo Ricca in dialogo infinito
Gabriella Caramore
10 Settembre 2024
In una conversazione radiofonica del 2016 (Uomini e Profeti, Radio3), Paolo Ricca, pastore e teologo della chiesa valdese, morto a Roma nella notte fra il 13 e il 14 agosto 2024, affrontava l’oscurità di ogni discorso sulla morte ricorrendo sì alle Scritture e alle acquisizioni della scienza contemporanea, ma assottigliando via via ogni certezza, riconoscendo che ogni cultura ha elaborato “visioni fantastiche” intorno alla morte, senza però accontentarsi di quello che diceva una nota scienziata, secondo la quale ciascuno di noi si ridurrà a una “molecola” vagante nell’universo. Certo, il corpo se ne va. Ma non credo, diceva, che la “persona” possa ridursi a una molecola. È vero che la morte cancella la vita, tuttavia non dissolve la “persona”. Qualcosa rimane. Non solo nella memoria dei vivi, ma in quella che lui chiamava la “memoria di Dio”, e che noi potremmo chiamare una grandezza che ci trascende, un “oltre” in cui non valgono più le categorie “terrene” di spazio e tempo, ma che pure esiste anche se per noi rimane invisibile e inconoscibile.
Chissà. Forse è così che si riesce a sopportare la scomparsa dal nostro orizzonte delle persone che ci sono state care. E che si sono spese fino in fondo in ogni momento della loro vita per rispondere a chi chiedeva qualcosa, qualunque cosa. Tenendoli vicini nella memoria. Ma anche collocandoli in un luogo dell’assenza nel quale una qualche impalpabile forma di presenza è custodita.
In ogni caso, oggi che la morte di Paolo Ricca è appena accaduta, e per questo ci appare così irreale, quasi impensabile per chi lo abbia conosciuto, il suo profilo è più vivo che mai. La cosa che colpiva di più, immediatamente, chiunque lo incontrasse e avesse la possibilità di ascoltarlo era il suo linguaggio. Nelle omelie, nelle conferenze, nei dibattiti pubblici, nei dialoghi radiofonici a imporsi era soprattutto l’impostazione della voce: robusta e sussurrata, sospinta come da un moto ondoso e spezzata da una pausa, una sottolineatura, un dubbio in forma di silenzio. Ma a sostenere l’impianto oratorio – inconfondibile – vi era una struttura geometrica del pensiero, basata su solide fondamenta: una passione inesausta per la Parola biblica; una fedeltà non passiva, ma continuamente interrogante, alla tradizione del protestantesimo e della riforma, in particolare al pensiero di Lutero (di cui ha curato e in parte tradotto tutti i volumi delle Opere scelte presso l’editrice Claudiana di Torino); un attaccamento affettivo ma anche convinto alla comunità valdese da cui proveniva (era nato, figlio di pastore, a Torre Pellice il 19 gennaio 1936); una fede incrollabile, ma non dogmatica, nel Dio delle Scritture; e una fede altrettanto forte e incrollabile nel rapporto e nel dialogo con persone di altre fedi e di altre convinzioni.
Ho avuto moltissime occasioni di sperimentare che cosa fosse per lui “dialogare”. Soprattutto nel corso dei lunghi cicli di trasmissioni a Uomini e Profeti, dove è stato fedele e seguitissimo ospite per quasi tutto l’arco di tempo in cui ho curato e condotto la trasmissione. Ogni anno realizzavo con lui un ciclo di trasmissioni, che potevano essere dedicate alla Predestinazione, o alle Dieci parole di Dio, o a Lutero, o a Calvino, o al Padre nostro, o al Vangelo secondo Giovanni, o alla Genesi, o all’ Alba del cristianesimo, o alle Lettere di Paolo apostolo. Ogni volta, nel corso dei 45 minuti di ogni singola puntata, e di ogni singolo ciclo di puntate, colpiva l’acribia esegetica, ma anche la minuziosa ricostruzione del contesto storico, e il raffronto con le interpretazioni delle diverse confessioni e tradizioni, per arrivare poi – quasi lasciando affiorare pensieri sotterranei che lo avevano guidato in tutta la costruzione della sua esposizione – a mettere in chiaro “con timore e tremore” si potrebbe dire, ciò che di più personale emergeva in quelle meditazioni, e nello stesso tempo le risposte che, a suo avviso, le Scritture potevano offrire alle questioni contemporanee. Ma senza forzature, sapendo, e lo ripeteva spesso, che non tutte le parole della Bibbia hanno lo stesso valore, che nella vita – anche e ancor più in quella religiosa – rimane una porzione di “enigma” di cui non si viene a capo, sapendo che “Dio non è un’evidenza”, può essere solo una traccia di luce che, per alcuni, illumina la strada. Ma che altri, forse, possono trovare in altre sorgenti gli stessi bagliori di luce.
Per questo, pur essendo bel saldo nelle sue convinzioni di fondo, amava confrontarsi con le sfide della contemporaneità. Forse era propria la difficoltà dell’impresa a sollecitarlo, a stimolare il suo pensiero a farsi aperto, azzardato. E a volte ritratto.
In uno degli ultimi incontri pubblici in cui l’ho visto animarsi, nel marzo di quest’anno, pochi mesi prima di dover affrontare gli ultimi cedimenti del corpo, è stato al Teatro Comunale di Corato (Bari), una città che gli era molto cara e dove aveva affezionati amici – come del resto in tantissimi altri luoghi, grandi e piccoli, del nostro paese, dove a tutti veniva riservato lo stesso coscienzioso impegno e la stessa empatica attenzione. Lì, a Corato, ad esempio, ha tenuto una appassionata e veemente relazione sullo stato in cui versa l’Europa, sottolineando con drammaticità che cosa significa per la contemporaneità la perdita di tre dimensioni del tempo: quella dell’aldilà, intendendo con questa espressione una ulteriorità che tracimi dal contingente; quella di un’Europa e di un Occidente come patria di quella che fino ad ora abbiamo considerato democrazia; la fine del tempo in cui il nostro pianeta appariva come un luogo sicuro. A queste derive del tempo storico contrapponeva una dimensione del tempo nella prospettiva cristiana come nuovo inizio, una sollecitazione a restare vigili, e ad avere il coraggio delle scelte. Constatando però come il cristianesimo stesso non sia più in grado di “leggere i segni dei tempi”. Ma questo, per Paolo Ricca, non significava una “resa”; bensì la necessità di aprire una nuova stagione di “resistenza”.
Certo, questo è un momento critico per ogni forma di teologia. Stenta, e a ragione, un “discorso su Dio”. La teologia è in crisi pressoché ovunque: nel mondo occidentale, che ne è stato la culla, e che oggi è pressato e sollecitato da altre modalità del pensiero; e nei “nuovi mondi” che stanno in bilico tra antiche tradizioni e nuove urgenze. E tuttavia Paolo Ricca è sempre stato convinto che il discorso su Dio non è chiuso. Per lo meno, non è ancora il momento di rinchiuderlo nelle teche dei musei, ma se ne può ancora raccogliere quell’“acqua viva” che ha dissetato e nutrito tante infelicità e tante gioie nella storia. Di qui la fretta degli ultimi anni di raccogliere molti dei suoi pensieri intorno a ciò che lo aveva tenuto in vita, in un esercizio di gratitudine al Dio in cui credeva e alle creature tutte, perché da tutte aveva appreso qualcosa. Ricordo soltanto gli ultimi due libri, pubblicati in una nutrita collana della editrice protestante Claudiana: Dio. Una apologia, e Secondo Marco. Ma credo che le sue parole rimarranno vive anche proprio perché le sapeva porgere ogni volta con convinzione profonda. Ogni interlocutore, anche il più piccolo e talvolta il più improbabile, meritava la stessa considerazione e lo stesso impegno di quelli più grandi e autorevoli. Nelle dediche che faceva dei suoi libri, il nome del destinatario era sempre scritto in rosso, quasi a sottolineare una linea del cuore che deve unire ogni essere vivente a un altro. Ad ogni dialogo, o conferenza, o trasmissione si preparava con uno scrupolo e un impegno come se da ogni occasione, anche la più fuggevole, dipendesse la sorte di Dio su questa terra. Erano diventati leggenda i suoi foglietti di appunti, ordinatissimi e pienissimi, quasi che lasciare uno spazio vuoto fosse un insulto al tempo prezioso che ci è donato. Nelle occasioni conviviali, ed erano tante, sempre generose, gaie, e sempre supportate dalla sua famiglia, la lettura e il commento, accuratamente preparato, di un versetto biblico che le precedeva era sempre l’inizio di ore gioiose, allegre, affettuose. Mai stare con lui diventava occasione di qualche lamentela o di malevolenze o di cadute di tono. La sua gratitudine – per Dio, per la vita, per le persone incontrate – superava sempre in fedeltà e devozione quella che gli altri, comunque, sentivano nei suoi confronti.
Mi si consenta un ultimo ricordo personale. Quando, circa un anno dopo il nostro primo incontro e lavoro insieme (eravamo a metà degli anni Novanta), mi invitò a Torre Pellice, ad assistere ai lavori del Sinodo della chiesa valdese, che si tiene ogni anno a fine agosto, ospitandomi nella sua casa di famiglia, con sorelle, fratelli, figli, vecchie zie, amici e amiche, per me fu una immersione totale in un altro mondo rispetto alla dimensione di chiesa che fino a quel momento conoscevo. Vi si respirava una vitalità, una libertà, che mi lasciarono molto sorpresa, nella mescolanza di pastori e pastore con bambini, giovani, vecchi, con uomini e donne provenienti da altri mondi, in un vivacissimo clima di lingue, costumi, mentalità diverse. Il dinamismo del dibattito durante i lavori, a volte davvero acceso senza scadere in grossolanità, la forza delle preghiere e dei canti, la partecipazione di tutti era qualcosa che, ingenuamente, non mi aspettavo. Mi fu presto evidente che questo era il risultato da un lato della provenienza libertaria e pauperista del piccolo popolo valdese proveniente in epoca medioevale dal sud-est della Francia, insediatosi, in parte, nelle valli del Piemonte orientale, e lì rimasto chiuso in un ghetto naturale fino alle lettere patenti di Carlo Alberto nel 1848; dall’altro dalla adesione alla Riforma calvinista che lo aveva aperto, attraverso i contatti con la Svizzera, al mondo internazionale. Lo stesso Paolo Ricca, dopo aver studiato alla Facoltà Valdese di teologia di Roma (dove poi sarà docente per lunghi anni), aveva completato gli studi a Basilea, con Oscar Cullmann e Karl Barth, prima di altri soggiorni in Germania e negli Stati Uniti. Certo, ciascuno vi dava il suo apporto personale. Ma Paolo Ricca aveva un modo così speciale di essere pastore e teologo al tempo stesso, devoto ai suoi affetti e insieme alla comunità dei viventi, alla sua chiesa e alle ekklesìae del mondo intero, alla tradizione e alle provocazioni della contemporaneità, che davvero lascia – uso la parola più banale del mondo, ma anche l’unica vera – un vuoto immenso in chi lo ha conosciuto ma anche nella storia del nostro paese. Ora che tutte le chiese storiche conoscono una crisi profonda, come è inevitabile nel tumultuoso smottamento della nostra epoca, maggiore è la tristezza, e anche lo sgomento, quando uno dei grandi testimoni se ne va. Per questo credo sia importante rielaborarne la memoria e tenerne cara la presenza.
La commemorazione ufficiale avrà luogo il 16 settembre presso la Chiesa Valdese di piazza Cavour, a Roma, alle 17.00.
Se continuiamo a tenere vivo questo spazio è grazie a te. Anche un solo euro per noi significa molto. Torna presto a leggerci e SOSTIENI DOPPIOZERO
.

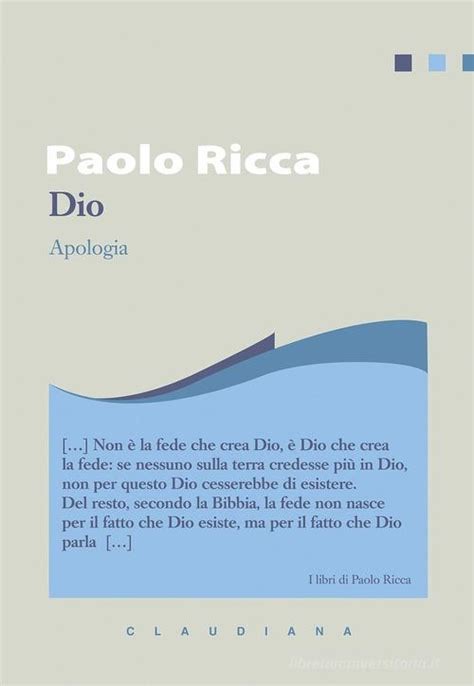



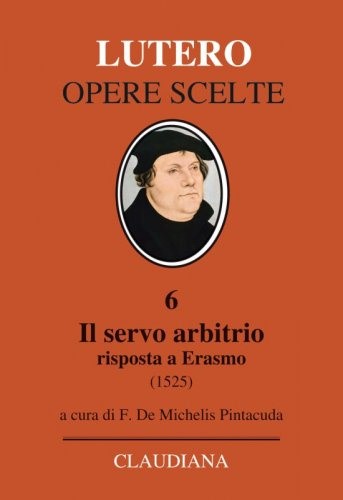

CARTELAMI: UNA “PASSIONE” DI CARTA
Doppiozero, 17 aprile, 2022
Gabriella Caramore
Strana Pasqua quella di questo anno 2022, che vede una guerra atroce, distruttrice, disumana violentare quella fragile pace che gli ultimi settant’anni sembravano avere acquisito. Una guerra che nasce nel cuore delle due Europe (quella d’Oriente e quella d’Occidente), ma sta mostrando un crescendo di implicazioni mondiali con prospettive terrificanti. Strana Pasqua, perché mentre dovrebbe, come tutte le Pasque, celebrare il memoriale di un uomo ingiustamente ucciso dalla crudeltà del mondo, e dunque spingere il cuore almeno dei cristiani a una conversione verso la fratellanza, la giustizia, la speranza, li vede in gran parte – almeno quelli più legati alle Chiese locali, soprattutto quelle d’Oriente, da sempre fortemente identitarie – su fronti contrapposti, pronti a odiarsi e a uccidersi l’un l’altro, pronti a rivendicare non un Dio di tutti, ma un Dio fortemente partigiano, il “Dio con noi” di famigerata memoria, che ciascuno può a suo piacere fare proprio. …
CARTELAMI: UNA “PASSIONE” DI CARTA
Gabriella Caramore

.Strana Pasqua quella di questo anno 2022, che vede una guerra atroce, distruttrice, disumana violentare quella fragile pace che gli ultimi settant’anni sembravano avere acquisito. Una guerra che nasce nel cuore delle due Europe (quella d’Oriente e quella d’Occidente), ma sta mostrando un crescendo di implicazioni mondiali con prospettive terrificanti. Strana Pasqua, perché mentre dovrebbe, come tutte le Pasque, celebrare il memoriale di un uomo ingiustamente ucciso dalla crudeltà del mondo, e dunque spingere il cuore almeno dei cristiani a una conversione verso la fratellanza, la giustizia, la speranza, li vede in gran parte – almeno quelli più legati alle Chiese locali, soprattutto quelle d’Oriente, da sempre fortemente identitarie – su fronti contrapposti, pronti a odiarsi e a uccidersi l’un l’altro, pronti a rivendicare non un Dio di tutti, ma un Dio fortemente partigiano, il “Dio con noi” di famigerata memoria, che ciascuno può a suo piacere fare proprio. Sì, lo sappiamo che gli esseri umani sono straordinariamente inventivi nel male come nel bene. Ma è inevitabile chiedersi: che cosa non è andato nella trasmissione della fede? Che cosa ha funzionato tanto male da produrre una tale babele capace di confondere la mitezza con la guerra, l’umiltà con la tracotanza del potere?
Il discorso è troppo ampio per poterlo affrontare qui. Ma penso a come nei secoli la pietà popolare venisse tenuta viva attraverso semplici rappresentazioni, che probabilmente avevano ben poco di filologicamente corretto, ma affidavano al racconto – o alla gestualità, o alla pittura, o alla musica – il senso ultimo del discorso pasquale: la vicinanza alla vittima e la speranza di un riscatto. In maniera semplice e diretta, affinché tutti potessero comprendere e partecipare.
Biblia pauperum era detta, fin dai primi secoli del tardo Medioevo, una forma particolare di spiegazione di alcuni testi o passi della Bibbia, che consisteva in illustrazioni, accompagnate da singoli versetti o spiegazioni, ad uso dei “poveri” che non avevano mezzi per accedere alle Scritture e dunque dei “semplici”, che si affidavano alla divulgazione di monaci particolarmente abili nelle raffigurazioni iconografiche delle Scritture. Nata come pratica nella Germania meridionale del Quattordicesimo secolo, si diffuse poi anche in Italia, Francia, Olanda, per “insegnare” con efficacia a una popolazione analfabeta gli episodi principali della vita di Cristo, aprendo così a un pubblico il più vasto possibile l’accesso alla via della salvezza cristiana. Più in generale, con la grande diffusione dell’arte sacra in Occidente, l’espressione “Bibbia dei poveri” venne attribuita anche a scene affrescate nelle navate di chiese e cappelle, soprattutto quando sono in sequenza, e narrano le scene bibliche da Genesi ad Apocalisse, con al centro, ovviamente, la figura di Cristo. Anche la Cappella degli Scrovegni, per esempio, può essere considerata una Bibbia dei poveri. Ciascuno, ignorante o sapiente, può riconoscervi le scene narrate, anche senza magari percepirvi le innovazioni prospettiche, l’impasto dei colori, la finezza delle interpretazioni. Chi potrebbe non capire la magnificenza di quel cielo stellato che sovrasta il visitatore e che avvolge le nostre vite?
Quando poi all’arte “sacra” si affiancò l’arte “profana”, e, parallelamente, si comprese che l’interpretazione dei testi biblici esigeva una complessità che andava al di là delle raffigurazioni dei monaci o degli artisti che si affermavano nelle grandi città, l’espressione Biblia pauperum – e la sua funzione – si affievolì e si fece da parte. Ma nelle piccole comunità, nei villaggi impervi nascosti tra boschi e rilievi montuosi, dove la grande arte non poteva arrivare e le sontuose manifestazioni liturgiche rimanevano un’eco lontana, continuò a lungo a sussistere la partecipazione a quel sacro evento, narrato come culmine del dolore dell’uomo, della malvagità del potere, della pietà consolatoria, e di una speranza di riscatto. Così, ad esempio, in molti villaggi dell’entroterra ligure, soprattutto nel versante di ponente, nacque, intorno alla metà del diciottesimo secolo, un’altra arte povera. Ma povera non solo perché destinata ai poveri, ma fatta dai poveri, dagli artigiani dei paesi: carpentieri, fabbri, pittori, e non necessariamente artisti di professione. Ma soprattutto povera perché realizzata con materiali poveri: semplice cartone, gesso, colla, strutture di legno, colori ricavati dai materiali quotidiani. E ai poveri destinata.
Franco Boggero, storico dell’arte, funzionario della Soprintendenza di Genova, e appassionato del paesaggio del Ponente ligure, da anni si dedica alla valorizzazione dei “giacimenti” culturali dimenticati della regione. Alla sua passione si devono molte riscoperte di cartelami in soffitte, sacrestie, cantine di diverse chiese e paesi. La conservazione di quei materiali la si deve, forse, a “quell’attitudine prudente, tipicamente ligure, che si esprime con il termine manimàn: magari, un domani, non si sa mai …”. Oggi si tratta di restaurarli, di riportarli alla luce, farli rivivere, e con essi far rivivere l’essenza dolorosa, ma che non rinuncia alla speranza, di quel racconto. Un esempio: nella Flagellazione di Sassello (FIG.1), in provincia di Savona, tutto appare come reale: Il Cristo percosso è un perdente come ce ne sono stati tanti, in ogni luogo e in ogni tempo, e la soldataglia che lo percuote sono i persecutori di sempre. Chi metteva “su carta” tutto questo erano i semplici abitanti del luogo, gli umili lavoratori, i “poveri” cui la “buona notizia” è destinata, oltre l’offesa, oltre la morte.
Chissà se c’è un rapporto tra l’aspra dolcezza del paesaggio ligure e questa forma d’arte? Secondo Franco Boggero il cartelami si ambientano, “con la loro evidente povertà, nella bellezza scabra del paesaggio dell’entroterra ligure che – soprattutto nel Ponente della regione – mantiene aree intatte: a Cosio, un paese dalle linee severe nell’alta valle Arroscia, l’oratorio ospita un insieme di semplicissime sagome della Flagellazione. Il restauro le ha rispettate nella loro traballante povertà” (Fig. 2).
Le forme erano sostenute da intelaiature appositamente create, a volte in armonia con l’architettura stessa della chiesa a cui erano destinate, altre volte, invece facilmente adattabili ad altre chiese o piazze o teatri. In ogni caso il culmine di quella operosità era raggiunto nella Settimana Santa, dove appunto il racconto raggiungeva il suo apice e il suo senso. Qui un Cristo al calvario con faccia da contadino, lì un soldato flagellante, a lato un Ponzio Pilato infingardo, una madre dolente, una Maria di Magdala luminosa e attonita. Figure paesane che incarnano, in quelle forme di carta, le storie della passione, ma rese vive – non più solo archetipi astratti – da quell’emergere dalla vita del paese, delle campagne, di quelle colline verdi circostanti, di quel sudare, e patire, e faticare la vita, e talvolta gioire.
Porto Maurizio resta tuttora, spiega Franco Boggero, il più importante “deposito” di cartelami. Se ne conservano nell’oratorio di San Pietro, e in quello di Santa Caterina.
Diverse le tipologie: dalle semplici sagome di cartone, alla “macchina” (un telaio pieghevole) concepita per ampliare l’altare, alle quinte arboree dipinte su tela e tese, a loro volta, su telai lignei sagomati (Fig. 3).
Ma la vicenda dei cartelami ha conosciuto una espansione anche al di fuori della Liguria. In Corsica (Fig. 4), che fin oltre la metà del Settecento resta un dominio della Repubblica di Genova, in Sardegna, nel basso Piemonte, in Toscana, con soluzioni di volta in volta diverse.
Salvare questi racconti di carta è opera di recupero di un’espressività umile, di legame della fede con il territorio, portatrice di una interpretazione che coglie la sostanza del testo biblico. Non è possibile, ovviamente, tornare indietro. E neppure è auspicabile trastullarsi in una nostalgia fuori luogo. La storia si trasforma, e trasforma la nostra relazione alle cose. Ma ripensare sì, sarebbe doveroso. E ripensare per esempio a quanto la rigidità delle dottrine, la pompa dei riti, la prossimità al potere abbiano potuto, nei secoli, corrompere le antiche parole che annunciavano la necessità della giustizia e della pace fino a farle diventare armi di inimicizia e di guerra.
Se continuiamo a tenere vivo questo spazio è grazie a te. Anche un solo euro per noi significa molto. Torna presto a leggerci e SOSTIENI DOPPIOZERO

Osvaldo Licini. La luna e il segreto del cosmo.
Artpod Ascolti d’arte
Doppiozero, 24 febbraio, 2022
Gabriella Caramore
Una luna bianca, quasi impastata di gesso – simile a quella chiara materia incerta che si vedrà, vent’anni dopo, nelle immagini del primo allunaggio – ma che qui ancora conserva tutta l’allusività stregata del mistero inviolato. Il volto un po’ attonito di un’antica dama sdegnosa, con i due corni che si allungano in forma di mani alate, una che lambisce l’estremo della tela, in alto, l’altra protesa verso il piccolo cuore offerto da una mano graziosa, giù in basso, nell’estremo angolo sinistro del quadro. …
Puoi ascoltare qui il testo in audiolettura: https://www.doppiozero.com/materiali/osvaldo-licini-amalassunta-1
La luna e il segreto del cosmo
La luna e il segreto del cosmo
Gabriella Caramore
Autore Licini Osvaldo
Titolo Amalassunta 1, 1949
 Una luna bianca, quasi impastata di gesso – simile a quella chiara materia incerta che si vedrà, vent’anni dopo, nelle immagini del primo allunaggio – ma che qui ancora conserva tutta l’allusività stregata del mistero inviolato. Il volto un po’ attonito di un’antica dama sdegnosa, con i due corni che si allungano in forma di mani alate, una che lambisce l’estremo della tela, in alto, l’altra protesa verso il piccolo cuore offerto da una mano graziosa, giù in basso, nell’estremo angolo sinistro del quadro. Ancora a sinistra, in alto, quasi a compensare la solitudine della luna, nel manto blu della notte macchiato di oscurità, una sghemba stella a cinque punte, dello stesso colore di gesso, senza alcuna pretesa di sfolgorante scintillio. Questa la Amalassunta 1, esposta per la prima volta alla Biennale di Venezia del 1950, assieme ad altre otto Amalassunte, quasi a inaugurare, dopo il lungo silenzio degli anni di guerra, un nuovo inizio nella pittura di Osvaldo Licini. I “Personaggi”, le “Amalassunte”, gli “Angeli ribelli”, gli “Olandesi volanti”, popolano ormai le sue visioni e le sue tele. Ritiratosi nella casa di famiglia di Monte Vidon Corrado, immersa nel quieto paesaggio marchigiano, la casa in cui era nato e dove era cresciuto affidato alle cure del nonno, si lascia lavorare da pensieri forti, nuovi, ribollenti. La sera, la notte sostava a lungo sull’altana della casa, a interrogare le profondità della terra e le vastità dei cieli, i profili delle colline e il giallo e il verde dei campi, in ascolto del cuore umano e del cuore del mondo. Ed ecco, sua compagna la luna, e gli angeli, e le figure in volo.
Una luna bianca, quasi impastata di gesso – simile a quella chiara materia incerta che si vedrà, vent’anni dopo, nelle immagini del primo allunaggio – ma che qui ancora conserva tutta l’allusività stregata del mistero inviolato. Il volto un po’ attonito di un’antica dama sdegnosa, con i due corni che si allungano in forma di mani alate, una che lambisce l’estremo della tela, in alto, l’altra protesa verso il piccolo cuore offerto da una mano graziosa, giù in basso, nell’estremo angolo sinistro del quadro. Ancora a sinistra, in alto, quasi a compensare la solitudine della luna, nel manto blu della notte macchiato di oscurità, una sghemba stella a cinque punte, dello stesso colore di gesso, senza alcuna pretesa di sfolgorante scintillio. Questa la Amalassunta 1, esposta per la prima volta alla Biennale di Venezia del 1950, assieme ad altre otto Amalassunte, quasi a inaugurare, dopo il lungo silenzio degli anni di guerra, un nuovo inizio nella pittura di Osvaldo Licini. I “Personaggi”, le “Amalassunte”, gli “Angeli ribelli”, gli “Olandesi volanti”, popolano ormai le sue visioni e le sue tele. Ritiratosi nella casa di famiglia di Monte Vidon Corrado, immersa nel quieto paesaggio marchigiano, la casa in cui era nato e dove era cresciuto affidato alle cure del nonno, si lascia lavorare da pensieri forti, nuovi, ribollenti. La sera, la notte sostava a lungo sull’altana della casa, a interrogare le profondità della terra e le vastità dei cieli, i profili delle colline e il giallo e il verde dei campi, in ascolto del cuore umano e del cuore del mondo. Ed ecco, sua compagna la luna, e gli angeli, e le figure in volo.
Ma perché quel nome, “Amalassunta”? Innumerevoli spiegazioni sono state fornite. C’è, dentro quel nome, la figlia del re ostrogoto Teodorico, per poco tempo anch’essa regina, come tutrice del figlio Alarico, presto assassinata nell’isola di Martana, sul lago di Bolsena. Una regina che lo aveva incantato fin da bambino. E poi, certamente, in quel nome vi è anche l’eco del dogma dell’Assunzione proclamato nel 1950: il “male” assieme all’ “Assunta” è un chiasmo che non poteva non intrigare Licini, accanito nel cercare il lato nascosto delle cose. Ma, alla fine, al di là di troppa filologia, è Licini stesso che svela l’intima essenza delle sue lune: “Amalassunta è la luna nostra bella, garantita d’argento per l’eternità, personificata in poche parole, amica di ogni cuore un poco stanco”. Poche le parole per dirla: l’argento che buca la soglia dell’eterno, chinandosi sul cuore di chi è “un poco stanco”. Anche Leopardi – su cui Licini aveva in mente un grande lavoro – nella sua Recanati, non molto lontana da Monte Vidon Corrado, osservava la luna dietro le stesse colline, a dar luce agli stessi paesaggi. Talvolta confidente e amica, talaltra distante e muta, o ancora beffarda giudice della terra. Ma in una giovanile Storia dell’astronomia la definisce “capace di recar soccorso all’uomo che veglia, e incapace di recar molestia all’uom che riposa”. Per entrambi, un ponte di consolazione tra il terrestre e l’ignoto.
Ma c’è qualcos’altro che sembra unire il poeta di Recanati e il pittore di Monte Vidon Corrado. Nelle tele e nei disegni del primo periodo, fino più o meno a tutti gli anni Venti, con fedeltà pari a quella del suo amico Morandi verso le sue nature morte, Licini dipinge i paesaggi della sua terra: colline, villaggi, scorci di paese marchigiani. Un albero, un borgo, una casa. Come la siepe leopardiana, profili che separano il contingente e l’immenso.
In una seconda fase della sua ricerca, più o meno gli anni Trenta, Licini entra in dialettica con i movimenti surrealisti presenti in tutta Europa. Affascinato e attratto da varie forme di astrattismo, comincia “a dubitare”, come lui stesso scrive ad un amico, che un’altra realtà si nasconda dietro quella visibile delle cose. Inizia così quello che lui stesso chiama un “surrealismo personale”, una svolta astratto-geometrica per cominciare a individuare il nesso tra il caos del soggetto e l’ordine dell’universo: geometrie rigorose, colori definiti, linee che rimandano a un tentativo di definire l’origine e la fine.
Poi, il silenzio negli anni della seconda guerra mondiale. Appassionato del mondo reale non meno che della raffigurazione pittorica (sarà per due mandati sindaco del suo paese) è scosso dalle vicende che percorrono l’Europa. Lui stesso aveva conosciuta l’insensata carneficina della prima guerra mondiale, da cui era tornato ferito. In quel periodo decide “di non mostrare, di non esporre e di non vendere, per tutta la durata della guerra”. Ma il suo non è un silenzio inerte, arreso. “Ti scrivo dalle viscere della terra, la regione delle madri, forse, dove sono disceso per conservare incolumi alcuni valori immateriali, non convertibili, certo, che appartengono al dominio dello spirito umano. In questa profondità ancora verde, la landa dell’originario, forse, io cercherò di recuperare il segreto primitivo del nostro significato nel cosmo. Cessato il pericolo …. riapparirò alla superficie con la diafanità sovraessenziale, e senza ombra. Solo allora potrò mostrarti le mie prede, i segni rari che non hanno nome, alfabeti e scritture enigmatiche, rappresentazioni totemiche, che solo tu con la tua scienza potrai decifrare”. Così scrive, il 1° febbraio 1941, a Franco Ciliberti, fondatore del movimento “primordialista”, che sarà nuova fonte di ispirazione per Licini.
“Vivere, allora, andare al di là di noi stessi, trascendersi. Ecco perché ancora viviamo con questa speranza” – scrive nel 1943. “Sicuro, niente è finito, tutto deve ricominciare”. Dopo la dissoluzione, il rinnovamento. Per avvicinarsi alla verità, occorre trasfigurare il mondo.
Ecco allora le figure fantastiche, in volo nell’aria, sospese nel cielo. Ecco le Amalassunte. Questo astro spento e vivo al tempo stesso, che appare a sotto mille volti, mutevoli come mutevole è l’universo.
Dopo lo sbarco sulla luna del 20 luglio 1969 ebbe inizio un grande dibattere tra scrittori, artisti, filosofi, se quella visione così ravvicinata del freddo astro lunare con avesse raggelato anche la fascinazione umana per il cosmo, non ne avesse mostrato il lato oscuro degli interessi politici e dello sfruttamento economico, indebolendone l’attrattiva per i poeti e i visionari. Ma a me sembra – e l’attenzione per la ricerca scientifica cresciuta a dismisura in questi anni lo testimonia – che i piccoli e grandi passi compiuti dalla conoscenza, non facciano altro che incrementare il desiderio di inoltrarsi nei misteri delle galassie sconfinate. L’Amalassunta di Osvaldo Licini, come le tante lune raccontate, dipinte, cantate, non ha perso l’incanto con cui la guardava il suo creatore. Al contrario, ci attira a sé nel desiderio “di recuperare il segreto primitivo del nostro significato nel cosmo”.
.
Se continuiamo a tenere vivo questo spazio è grazie a te. Anche un solo euro per noi significa molto. Torna presto a leggerci e SOSTIENI DOPPIOZERO

“PAROLE PER IL FUTURO”
DESIDERIO
Doppiozero, 24 gennaio, 2022
Gabriella Caramore
Desiderio: la materia più oscura dell’umano, sfuggente, non catalogabile, colorato di mille mutevoli tonalità. Il desiderio sembrerebbe essere il nucleo più segreto, insondabile, ingovernabile della natura umana. Perché allora pensare al “desiderio” come parola, e dunque esperienza, per aprire un varco ai nostri pensieri sul futuro? …
Desiderio
DESIDERIO
Gabriella Caramore
Desiderio: la materia più oscura dell’umano, sfuggente, non catalogabile, colorato di mille mutevoli tonalità. Il desiderio sembrerebbe essere il nucleo più segreto, insondabile, ingovernabile della natura umana. Perché allora pensare al “desiderio” come parola, e dunque esperienza, per aprire un varco ai nostri pensieri sul futuro? Potrà mai una dimensione magmatica come quella del desiderio diventare una delle pietre su cui poggiare per costruire futuro? Forse sì, proprio perché la sua irregolarità e prepotenza è l’essenza stessa del vivente. Ma allora occorrerà provare a capire che cosa possiamo intendere con “desiderio”, fatto salvo che, come tutte le parole fortemente simboliche, anche “desiderio” ha una lunga storia, che non potremo ripercorrere esaurientemente, e tenuto conto che, oggi, quello che è il carattere più intimo del desiderio, e cioè la sua libertà, è fortemente messo in questione dalla qualità invasiva e totalizzante del nostro sistema sociale, che tende non solo a orientare i desideri in funzione di scopi economici, come già accadeva nel capitalismo “classico”; ma ora anche a farli sorgere, crearne di nuovi, confonderli l’uno con l’altro, renderci schiavi e succubi di processi indotti, oscurando in noi le stesse fonti del desiderio. Se è messa in questione la sussistenza stessa del desiderio, come sarà possibile che esso divenga tratto essenziale per il nostro futuro? C’è una prima cosa da cui ritengo che si debba rifuggire: ed è di essere noi ad ingabbiare i nostri pensieri o le nostre emozioni dentro formule univoche, onnicomprensive, capaci di spiegare tutto e di dare ad ogni cosa o infinite vie d’uscita, per cui tutto sarebbe sempre ancora possibile, o di chiuderle dentro invalicabili sbarramenti, per cui nulla avrebbe più senso. Pensare che, anche nel nostro mondo automatizzato, nella nostra società “automatica” non ci possano essere squarci di opportunità, di aperture – questo sì è totalizzante, e questo sì alimenta una tentazione inerziale, e chiude futuro.
Occorre allora, per prima cosa, forzatamente, ritornare sull’etimologia di questa parola almeno in alcune delle lingue occidentali, quelle che hanno accolto l’origine latina della parola: appunto, de – sidera, lontano dalle stelle. E dunque, il ritrovarsi smarriti, senza mappa, senza la guida delle costellazioni celesti che orientano il cammino dei viandanti, sperduti, appunto, in una selva oscura, e ansiosi di rintracciare la diritta via. Ma le etimologie non devono servire, come spesso accade, a dare “l’esatto significato” di una parola ancora viva. Le parole sono, appunto, corpi vivi, in movimento, si trasformano, si arricchiscono, si impoveriscono, deviano, raccolgono gli umori del tempo, nuovi significati. “Desiderio” non è solo quel disorientamento che fa anelare a una mappa ordinata. È anche molto altro. È quella pulsione che ci porta a uscire da noi stessi, verso un altro cielo o verso “il sogno di una cosa” altra rispetto a quella che già conosciamo. È una spinta che ci induce a colmare una lontananza, che ci immette in una dimensione del tempo più vasta di quella quotidiana scandita dal tempo cronometrico. È deviazione dall’ovvio e dal consueto, esplorazione dell’ignoto, creazione di mondi fino a quel momento neppure immaginati. In questo senso è l’intera storia dell’umano che si articola e prende forma dentro l’ampio spettro del desiderio. E in questo senso riguarda il presente e il futuro della vita stessa.
L’immagine forse più vivida per raffigurare il desiderio è quella del vento. Si è invasi da un vento, quando il desiderio ci prende. Un po’ come è dello spirito, che non sai di dove viene e dove va, che soffia dove vuole, e dove vuole ci conduce. Ma, appunto, ben poco sappiamo di quale sarà il nostro destino, quando il desiderio ci afferra. Sappiamo solo che è uno stato dei più mutevoli, quello dell’essere preda del desiderio. Ce lo insegna il corpo, che quando è preso dal desiderio va verso un altro corpo, che ci attrae come il più ignoto e il più lucente degli universi. Ce lo insegna la nostra esperienza quotidiana, letta e studiata da filosofi e psicologi di tutti tempi. A partire da Aristotile, per il quale il desiderio è ciò che smuove le anime verso tutte le direzioni (dalla trasformazione del lavoro alla ricerca del divino), a Baruch Spinoza (il desiderio è l’essenza stessa dell’umano), a Ernst Bloch, per il quale il desiderio è avvinghiato alla irrinunciabile speranza. Tutte le storie narrate dai poeti, dall’epica, dalla letteratura: ci mostrano come l’essere umano sia mosso, nei suoi comportamenti, dal vento del desiderio, che ora soffia come brezza sottile, ora ci sospinge robusto verso terreni sconosciuti, ora ci travolge come un uragano.
Ma non volendo fare una fenomenologia del desiderio, questa premessa ci conduce invece a porci alcune domande.
La prima. Da dove nasce la nostra storia? Senza volermi improvvisare antropologa o paleontologa, mi sembra che tutti gli studi convergano a dimostrare che noi, homines sapientes, nasciamo da un desiderio di “oltre”. Sì certo, sarà stato anche il bisogno di difesa, di cercare determinati cibi, di costruirsi particolari ripari, ma la spinta così determinata alla posizione eretta, e dunque a un particolare sviluppo della mano, del piede, del cervello, io non riesco a non immaginarla se non come una piccola scintilla di desiderio, scoccata chissà come e chissà perché. Come accade in alcuni passaggi dei processi evolutivi, è qualcosa di contingente (se non vogliamo dire di casuale) a far sì che un percorso devii dal tracciato precostituito e inauguri un’altra storia. Una storia che ha inizio da un bagliore, appunto, da un soffio, da qualcosa che brucia nella mente, che fa distendere una mano, che dà una spinta a un piede, che accende un pensiero … Possono sembrare immagini “poetiche”, ma di fatto è così che iniziano le cose. C’è una intermittenza, una imprevedibilità nel processo evolutivo. È sempre qualcosa di imprevisto che apre un inizio e fa strada a una storia.
La seconda questione è la seguente. Sarebbe fuorviante cercare una definizione “unica” di desiderio. È più proficuo invece vederlo come un campo aperto di contraddizioni, all’interno del quale le variazioni sono pressoché infinite, le oscillazioni costanti, gli intarsi inesauribili. Noi possiamo anche provare a “classificare” i desideri. Ma non ne verremo a capo, tanto sono avviluppati e confusi e mai precisi dentro il cuore degli umani. Del resto, ci sono tante parole per determinare il campo semantico del desiderio: voglia, bramosia, sete, aspirazione, anelito, nostalgia. Ma, come vedremo, il sentire dell’essere che desidera è il più delle volte ingarbugliato, rimescolato, raramente lineare. Questo ci basta per capire in che maniera scompigliata il desiderio è parte imprescindibile dell’umano. I desideri nascono. I desideri muoiono. I desideri si riformulano. Per questo sono dentro la vita, e per questo ci riguarderanno finché vita ci sarà.
Sì, certo, “desiderio” è in primo luogo il tentativo di colmare una mancanza (le stelle oscurate). E ad uno stadio molto elementare si confonde con il bisogno. Basta pensare al sentire del bambino. Bisogno di cibo, certo, ma anche desiderio di un calore dolce che entra dentro e nutre e placa. Bisogno di sonno. Ma anche desiderio di un avvolgimento quieto, silenzioso, notturno. E così via. Già quando si passa al linguaggio si vede che il desiderio sovrasta il bisogno. Non ha bisogno di linguaggio il bambino per comunicare che ha fame, sonno, prurito, febbre. È sufficiente il pianto. Ma quando lo si vede teso, proteso nella lallazione, nei primi balbettii, nelle prime articolazioni del linguaggio, è il desiderio che lo muove. Di che cosa? Di relazione, di gioco, di invenzione, di prova di sé, di incontro. Non è solo bisogno. È desiderio. Così come le raffigurazioni rupestri di scene di caccia, di mani che si aprono, di animali, in ogni caso di forme. Non sono linguaggi per comunicare qualcosa; sono linguaggi mossi da un desiderio, che dice: ecco, io sono; ecco, io ho visto; ecco, io vi mostro. C’è indubbiamente un segreto nelle prime pitture rupestri. Ma nel voler “scrivere”, “rappresentare” ciò che è accaduto, si traccia una demarcazione tra bisogno e desiderio. Si scava un solco dentro il silenzio della storia e si scrive il mondo. Anche questo è frutto del desiderio.
Poi c’è un terzo passo che vorrei ancora compiere, prima di arrivare a porci il problema di che cosa sia o possa essere il desiderio nel tempo presente e nel futuro che possiamo immaginare.
Il desiderio, che, lo ripeto, si esprime in una gamma vastissima di manifestazioni, oscilla tra due fuochi fondamentali, due apici, due estremi.
Il primo estremo è una forza centripeta che sostanzialmente risucchia il soggetto – la persona – all’interno di sé. Questo accade quando si desidera con cupidigia, si vuole per sé, si identifica l’oggetto del desiderio come un prolungamento di sé – non occorre essere psicologi per affermare questo – mentre la persona o la cosa desiderata non è che appendice del soggetto stesso. Questo accade quando il tentativo di colmare quel vuoto, quella mancanza diventa una voragine all’interno, e si vorrebbe riempirla con qualcosa che non basta mai, come se la voragine continuamente si aprisse e divorasse ciò di cui la si riempie. Il desiderio si fa assillo. Pensiamo all’ossessione per la ricchezza. La ricchezza, di per sé, non è una cosa da disprezzare. Neppure la Bibbia disprezza moralisticamente la ricchezza. È segno che si è saputo mettere a frutto i propri talenti. Che si può essere larghi e generosi nei confronti degli altri. Ma quando la ricchezza è meta di una brama insaziabile, scordando che il desiderio nasce per andare verso un altro, allora diventa rapina, implica furto, menzogna, sfruttamento, abuso. Tanto per stare sulla cronaca, buttiamo un’occhiata al discusso Don’t Look up.
 Quando la brama di possesso si occulta dietro i volti inetti e avidi dei potenti, ma talvolta anche dietro quelli più apparentemente benevoli, più ingannevolmente “democratici”, quando si realizza alla faccia (e più spesso a costo) dei sacrifici di classi intere di popolazione, dello sfinimento degli umili, a volte fino ad ucciderli – allora quel desiderio sa di morte. Non è un vento ridente di primavera. Ma un vortice che trascina verso il basso. Verso la distruzione, verso la vergogna, anche se nessuno dei vip e dei capi di stato e dei re e dei banchieri che governano questo mondo prova vergogna. Siamo noi che proviamo vergogna per loro. Per quel vento sporco di fango, di miseria morale, di putrefazione.
Quando la brama di possesso si occulta dietro i volti inetti e avidi dei potenti, ma talvolta anche dietro quelli più apparentemente benevoli, più ingannevolmente “democratici”, quando si realizza alla faccia (e più spesso a costo) dei sacrifici di classi intere di popolazione, dello sfinimento degli umili, a volte fino ad ucciderli – allora quel desiderio sa di morte. Non è un vento ridente di primavera. Ma un vortice che trascina verso il basso. Verso la distruzione, verso la vergogna, anche se nessuno dei vip e dei capi di stato e dei re e dei banchieri che governano questo mondo prova vergogna. Siamo noi che proviamo vergogna per loro. Per quel vento sporco di fango, di miseria morale, di putrefazione.
Oppure, su un piano più individuale, e purtroppo tragicamente e eternamente attuale, quando un uomo uccide la sua donna, o quella che è stata la sua donna, perché non è più “per” lui, non è più la “sua” appendice, non è più il “suo” prolungamento – è ancora un desiderio che conduce i gesti di quell’uomo. Ma un desiderio che, ancora, non vede più l’altro libero, indipendente, autonomo; vede solo l’offesa ricevuta, la ferita, la voragine, appunto, che l’indipendenza dell’altro torna ad aprire. E allora ecco la violenza, le minacce, la morte. E a volte la voragine è tale che inghiotte anche il soggetto stesso. Eppure, anche questo gesto di morte nasce da quello che è stato un desiderio. Un desiderio malato, deviato, corrotto. Centripeto, appunto. Ma pur sempre desiderio. Perché c’è pur stato un momento in cui questa forza si è volta verso un altro, un’altra. C’è pur stato un momento in cui l’altra, o l’altro è apparso come qualcosa che poteva trascinare fuori da sé. Ma lì davvero è mancata, e manca, una educazione dei sentimenti, in primo luogo. E anche una educazione a un desiderio che non umili la libertà dell’altro a vantaggio del proprio arbitrio, che rispetti il desiderio anche dell’altro (intendendo non solo un singolo, ma anche la comunità umana e terrestre), avendo a fondamento una devozione verso l’uguaglianza degli esseri umani e verso l’esistere di ogni cosa.
Ma ecco, a fronte di questa punta estrema del desiderio, al limite opposto, vi è invece il desiderio che non si chiude su di sé, ma che si apre, si dilata, va più in là, fin dove è possibile arrivare. È un desiderio di “oltre”, di “alterità”, che ha a sua volta sempre accompagnato la storia della vicenda umana. È il desiderio che muove all’amore per un altro essere umano, senza pretendere che sia una protesi di sé stessi. Certo, questo amore è anche fatica, come sa chi costruisce una famiglia, o chi vive una relazione di coppia. È anche rinuncia, equilibrio, riassestamento ad ogni scossa, accettare che il vento del desiderio si plachi in una brezza sottile, come una piccola brace che può sempre riaccendere un fuoco. Ma è anche il desiderio che vivifica quell’ “amore che non muore”, di cui parla l’apostolo Paolo. Quel desiderio che fa sì che un essere umano si sporga oltre sé stesso, e si chini – che so – ad accogliere un animale ferito, a salvare i profughi in mare, a ricostruire identità smarrite, ad aver cura del vivente che gli è dato di incontrare. Quello stesso desiderio che si muove in campo aperto è quello che sostiene anche il peso e la leggerezza della danza, la cura nel trovare le parole esatte, la dedizione alla musica, la costruzione della poesia, la progettazione di bellezza in una città, la conservazione di un paesaggio, la ricerca di leggi che ci avvicinino sempre di più all’irraggiungibile giustizia, che muove la ricerca scientifica a voler capire come si possa rintracciare ordine nel grande disordine dell’universo. Come il volo di Icaro, in cui bellezza, ardimento, pericolo si fondono insieme, il desiderio trascina verso l’apertura di una frontiera, l’oltrepassamento di un limite, uno spalancamento di orizzonti. È dentro quel vortice che si apre in una spirale ascendente che nasce anche il desiderio che vi sia un dio, che vi sia un garante dell’ordine e del senso dell’universo. È questa pulsione verso un oltre che ha aperto quella che si continua a chiamare la ricerca del “trascendente”.
Certo le contraddizioni che accompagnano il movimento del desiderio sono infinite.
Intanto, se è vero che esiste un desiderio “voragine e chiusura” e un desiderio “apertura e respiro” vuol dire che uno è “cattivo” e l’altro “buono”? Uno che va corretto e l’altro che va esaltato? E allora dove va a finire la libertà del desiderio? Esiste un’etica che lo deve orientare e guidare? Ma ha senso parlare di etica a proposito di quel vento del desiderio così difficilmente orientabile? Certo, una prima risposta è fin troppo facile. Ma chi sarà in grado di decidere davvero? Esistono delle leggi tali da prevenire i guasti del desiderio “cattivo” e da favorire i risultati di quello “buono”? Sì, certo, una prima risposta è fin troppo facile. Quando un desiderio va contro la vita, la libertà, la costruzione di un mondo o di una persona occorre intervenire per salvare chi è vittima di quella pulsione distruttiva: sia essa una donna, un uomo, un ambiente, una comunità. Là dove un desiderio si esprime invece in costruzione di senso, in aggiunta di bellezza, in difesa di un bene individuale o comune si dovrebbe lasciargli tutto lo spazio di cui ha bisogno. Ogni libertà, è evidente, non è illimitata. Ma deve trovare il suo limite nella libertà dell’altro, nel libero esprimersi del desiderio dell’altro. Quali criteri possono dirimere però le questioni? Non ci sarà mai una legge definitiva. Sappiamo che le leggi non bastano. Esistono però dei criteri che si debbono di volta in volta discutere, contrattare, elaborare. Esiste una continua evoluzione dei confini di questa libertà, sostenuta da una responsabilità individuale e collettiva. Sarebbero mille gli esempi sui quali ci potremmo esercitare.
È contraddittorio anche il fatto che in questo nostro tempo, che qualcuno ha chiamato “l’epoca delle passioni tristi”, da un lato si lamenti la fine di una dimensione autenticamente desiderante (fine, o sfinimento, del desiderio sessuale, del desiderio amoroso, di una pulsione progettuale, della passione politica, di creatività in ambito artistico). E d’altronde, già Leopardi, nel canto “A me stesso”, piangeva il prosciugamento del desiderio, che si accompagnava allo spegnimento della stessa speranza. “Non che la speme, il desiderio è spento …”. Ma d’altro canto invece si denuncia uno sconsiderato proliferare di egoistici e insensati desideri, indotti, appunto, non più soltanto dalla cosiddetta società dei consumi, ma da quella che viene chiamata “società automatica” (Bernard Stiegler), che orienta e determina le nostre scelte a volte senza che neppure ce ne accorgiamo,- dunque in realtà non sono scelte in senso proprio – in una continua produzione e fagocitazione di oggetti, di energie, di tecniche, in un processo che tutti più o meno avvertiamo come una “minaccia di disintegrazione”. E in effetti, prendiamo un singolo evento della nostra giornata, e consideriamo se davvero fino in fondo siamo liberi nelle nostre scelte o fino a che punto i nostri desideri vengono canalizzati, governati, polverizzati, e che lotta bisogna ingaggiare ogni giorno per salvaguardare quel poco di autonomia che riusciamo a sottrarre agli algoritmi predisposti da chissà chi. Dove va a finire il desiderio se trova mille ostacoli nella sua non dico realizzazione, ma nel suo farsi strada dentro di noi?
E tuttavia, non rischiamo così di avere una visione troppo perfetta, troppo assoluta, troppo totalizzante – in definitiva, idealistica – della società in cui viviamo? Fino a che punto il desiderio stesso è manipolabile dai meccanismi della società contemporanea? Non c’è, piuttosto, uno strappo, un buco nero nel quale il desiderio sfugge alle costrizioni del sociale e si manifesta nella sua libertà e dunque anche nella sua responsabilità? I neuroscienziati ci dicono che il problema che ancora non hanno risolto è come i comportamenti biologici diventano “coscienza”. Non potrebbe il desiderio – così prossimo al nucleo oscuro della coscienza – essere un buon campo di sperimentazione di questa liberà dell’umano?
Sì, forse è vero che siamo davvero dentro una mutazione antropologica – pensiamo alle vertiginose conquiste delle neuroscienze – in cui certamente le fonti del desiderio vengono corrose e corrotte. Ma non sarei così sicura che tutto questo “automatismo” funzioni così alla perfezione da annientare le scomposte reazioni del vivente. Dentro le quali il desiderio – la pulsione verso un “oltre”, un “di più”, un “altrimenti” – possa trovare ancora una strada, una cornice in cui esprimersi. Non è un pensiero “ottimistico” questo o consolatorio, tanto per non lasciarci con l’amaro in bocca. Io credo che sia invece molto realistico. Una specie di fuoriuscita da un pensiero monopolizzante e in definitiva un po’ idolatrico. Qualcuno ha detto: “L’algoritmo annienta tutto il resto”. Mi pare difficile credere a questa compattezza del reale. I movimenti stessi degli universi ci inducono a pensare che tutto è molto più movimentato, imprevedibile, paradossale. Allo stesso modo ci sono spinte, pulsioni, movimenti dell’intelligenza e del cuore del vivente che mostrano certamente una crisi profonda delle coordinate che hanno guidato tutto il Novecento; ma anche nuove modalità di pensiero, nuovi orizzonti da esplorare, nuove “invenzioni” da provare. Non a caso, credo, un teorico della “società automatica” come Bernard Stiegler proprio nella capacità di “creare” intravvede una modalità di “resistenza” all’annientamento dell’umano. Sempre, di nuovo, non abbiamo risposte formulate. Ma strade da intraprendere, fessure attraverso cui spiare il mondo, fessure per accogliere la luce e la sua fatica… Non è detto che tutto questo servirà a salvare il mondo. Il nostro mondo, quello che conosciamo, è a rischio estinzione. Lo sappiamo. Ma non è un buon motivo per non accettare la sfida, per non mettere alla prova il nostro desiderio di desiderare..
.
Se continuiamo a tenere vivo questo spazio è grazie a te. Anche un solo euro per noi significa molto. Torna presto a leggerci e SOSTIENI DOPPIOZERO
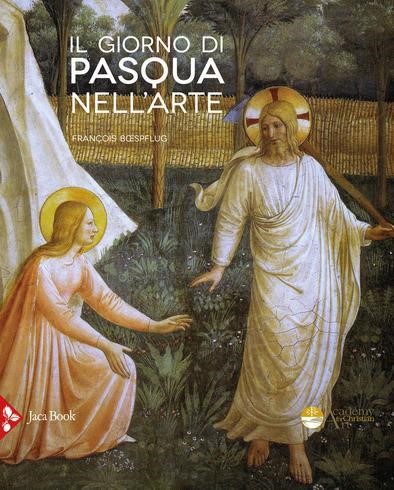
La Pasqua nell’arte
Doppiozero, 4 aprile, 2021
Gabriella Caramore
Nei quattro Vangeli il giorno di Pasqua, tutto ciò che ruota intorno all’“evento” della Resurrezione, è narrato con il riserbo dovuto a un accadimento inspiegabile, inaudito, indecifrabile anche per gli stessi discepoli e per i seguaci di Gesù di Nazaret, l’uomo ingiustamente crocifisso dai poteri congiunti delle autorità religiose e politiche. Descrivono infatti gli evangelisti, con la libertà della memorialistica e non con l’intento che noi oggi attribuiamo a una operazione storiografica, lo sconcerto dei discepoli e dei seguaci di Gesù intorno a quello che era accaduto a Gerusalemme: …
La Pasqua nell'arte
Gabriella Caramore
Nei quattro Vangeli il giorno di Pasqua, tutto ciò che ruota intorno all’“evento” della Resurrezione, è narrato con il riserbo dovuto a un accadimento inspiegabile, inaudito, indecifrabile anche per gli stessi discepoli e per i seguaci di Gesù di Nazaret, l’uomo ingiustamente crocifisso dai poteri congiunti delle autorità religiose e politiche. Descrivono infatti gli evangelisti, con la libertà della memorialistica e non con l’intento che noi oggi attribuiamo a una operazione storiografica, lo sconcerto dei discepoli e dei seguaci di Gesù intorno a quello che era accaduto a Gerusalemme: il profeta che aveva promesso la salvezza per Israele, il rabbi che aveva annunciato la riedificazione del tempio era stato condannato a una morte vergognosa sulla croce dei reprobi, e per di più il suo corpo non si era più ritrovato dentro il sepolcro custodito dai soldati romani. Ma forse quei racconti contraddittori, quell’incertezza nel disegnare i confini di un evento sperato ma non testimoniato, quei chiaroscuri di parole che lasciano nell’ombra della notte la “verità” dei fatti vogliono soltanto, forse anche consapevolmente, suggerire che non è la realtà fattuale che conta, non la cronologia degli eventi, non le affermazioni degli angeli, non le visioni delle discepole e dei discepoli. Bensì lo “spirito” che ha dato senso alla storia terrena di un uomo chiamato Gesù e vissuto nella Palestina sotto il dominio di Roma: uno “spirito” di misericordia e di giustizia, di rovesciamento dell’ordine del mondo, che insegna a guardare la storia “dal basso”, che mostra la necessità di operare secondo una logica che non sia solo quella dei potenti, ma che operi per la cura del mondo, per il diritto degli offesi, e per la tenerezza verso le creature.

Tutta l’arte cosiddetta “cristiana”, sia d’Oriente che d’Occidente, ha provato a narrare visivamente la grandezza di questo “sogno”. Ripercorrere i suoi momenti iconografici cruciali, così come sono narrati nei quattro Vangeli canonici, con qualche incursione anche
nei Vangeli apocrifi, è l’obiettivo del volume Il giorno di Pasqua nell’arte di François Boespflug, teologo, storico dell’arte, e storico delle religioni, autore di numerosissime pubblicazioni sulla cosiddetta “arte sacra”, molte delle quali tradotte, come questa, per i tipi della Jaca Book. Boespflug lo fa mettendo in luce via via alcuni episodi dei racconti biblici, scegliendo tra quelli più significativi, operando degli “ingrandimenti” di alcune vicende, o gesti, o figure, curandosi talvolta di rispettare la lettera degli scritti, talaltra invece prescindendo dallo scritto, e liberamente interpretando. Così, ad esempio, quando Rembrandt vuole raffigurare l’episodio dei discepoli di Emmaus, in un olio su tavola del 1648, L’ultima cena in Emmaus (fig. 58), ne dà una rappresentazione sostanzialmente fedele allo scritto, scegliendo il momento in cui Gesù, allo spezzar del pane nella casa dei due viandanti, si fa da loro riconoscere. L’ambiente è austero, il tavolo è poveramente imbandito, l’atmosfera quieta, il volto del Cristo tutto sommato non particolarmente espressivo.

Diversamente, lo stesso episodio descritto da Caravaggio nella Ultima cena in Emmaus di Londra (fig. 60), il banchetto è fastoso, tipicamente rinascimentale, i discepoli compiono gesti plateali, il Cristo appare consapevole della sorpresa indotta dalla rivelazione. Qui tutto
è lasciato alla coloritura dello stupore, mentre nel quadro di Rembrandt nulla sembra fuoriuscire dallo scabro racconto evangelico, ma tutto forse dà più da pensare. Un altro esempio. Difforme dalla lettera dei Vangeli, uno splendido affresco del monastero copto di Sant’Antonio il Grande, in Egitto, Il risorto appare a sua madre e a una santa donna (fig. 34), del XIII secolo, raffigura, appunto, un episodio che i Vangeli non raccontano, e cioè l’apparizione del Risorto a Maria, ma che una certa tradizione mariana presente nella Chiesa fin dalle origini, e più tardi un cattolicesimo devoto hanno voluto nei secoli assecondare. Qui, pur nella semplicità del muro affrescato, sontuose sono le decorazioni che ornano la volta, il Cristo – una mano che sorregge il Libro mentre l’altra benedice – è solenne e benevolo al tempo stesso. Una delle due donne gli sta ai piedi con gesto affettuoso, la madre senza guardarlo in volto apre le mani quasi ad accogliere la sua benedizione. I colori ocra, rosso scuro, bruno, blu scuro accentuano l’intimità del momento. Qui non vi è nulla che rimandi alla “verità” del testo, ma certamente l’autore restituisce la verità del suo “credo”, assieme a quella del suo tempo, e fa arrivare fino a noi il riverbero di qualcosa di semplice e al tempo stesso solenne: un uomo e due donne che si incontrano, l’amore che circola tra loro, ma che include – l’inclinazione dei volti e i movimenti delle mani lo rendono evidente – un amore per il mondo che non ammette revoche. Ma, appunto, ciò che conta non è il rispetto o meno della lettera del testo, ma ciò che gli artisti hanno saputo cogliere, in profondità, attraverso gli episodi e i simboli narrati, e innervati nei loro propri pensieri e in quelli del loro tempo, dello straordinario messaggio che quella vicenda riesce a veicolare fino a noi. Così, ad esempio, mentre un affresco del Monastero di Mileševa in Serbia Le mirofore al sepolcro (fig. 6), con quel possente angelo bianco seduto sulla tomba vuota ci sgomenta con le sue ali spalancate sul mistero della morte e dell’eterno; la Maddalena che torna indietro dalla tomba vuota, di François-Xavier de Boissoudy, un inchiostro acquarellato su carta del 2015, quasi ci imbarazza con le sue fattezze di ragazzona felice, che spalanca le braccia all’amato ritrovato. François Boespflug compie un’operazione originale nel comporre le scansioni di questo libro. Vuole raccontare, attraverso le opere d’arte, i diversi momenti di quella lunga giornata di Pasqua, che diede inizio a quella che nella Chiesa è chiamata la “fede pasquale”. Le ore diverse corrispondono ai capitoli del libro, ma corrispondono anche, sostanzialmente, alle “prese di coscienza dei testimoni oculari”. Si comincia con l’arrivo delle donne al sepolcro, nelle prime ore dell’alba, per portare gli unguenti che avrebbero profumato il corpo del loro maestro, e con lo sgomento per la scoperta della tomba vuota. Si prosegue con l’incontro che il Risorto ebbe con alcune donne, e in particolare con Maria di Magdala, come raccontato nel Vangelo di Giovanni. Mirabile, qui, la descrizione che ne fa Giotto nella Cappella degli Scrovegni, ma anche la sensualità appena trattenuta che prorompe dai dipinti del Correggio, di Giulio Romano, di Paolo Veronese.

Ci si avventura poi nell’annuncio della Resurrezione agli apostoli, dove spiccano le raffigurazioni dei discepoli di Emmaus. E non posso non citare qui ancora Rembrandt, che rende con audacia esegetica straordinaria la sparizione del corpo del Cristo, di cui rimane solo una memoria di luce. E accanto anche lo scarno ma potente rilievo in pietra del XII secolo nella abbazia benedettina di Santo Domingo de Silos, Burgos. Infine le apparizioni di Gesù agli undici raccolti nel Cenacolo, intenti a discutere quello che le donne arrivate per prime al sepolcro avevano loro raccontato. Tra questi, il celeberrimo episodio della dubbiosità di Tommaso. Da ultimo, l’epilogo con l’Ascensione a Betania, raccontata solo dal Vangelo di Luca, e ripresa poi negli Atti degli Apostoli. Dice Boespflug che “è proprio questa laboriosa genesi della verità, confusa ma avvincente, così profondamente umana” che gli ha dato l’idea di comporre questo itinerario, basandosi sulla scansione oraria degli eventi di quel giorno, e sulle testimonianze di coloro che hanno cercato o si sono “incontrati” con il risorto in quella memorabile giornata. E in effetti non è né la veridicità del racconto, né quella dei “credo” conficcati nei secoli che interessa cogliere a noi oggi, “uomini postumi”, come direbbe Musil, ma, appunto, una verità dell’umano. Sappiamo d’altronde che già i Vangeli non solo non sono storia, ma ciascun Vangelo è già una interpretazione “teologica” di quella particolare vita, di quel particolare insegnamento, di quelle parole e di quei gesti che sono entrati nella storia d’Occidente. E neppure dall’arte ci aspettiamo interpretazioni definitive. Piuttosto, ci accade di rimanere storditi dalla stupefacente capacità dei singoli artisti di trasfigurare nella bellezza di un’opera la loro densità di interpretazione, di trasferire in un dettaglio quello che nei primi anni del Novecento Vasilij Kandinskij chiamerà lo “spirituale nell’arte”. In questo senso è certamente di rilievo il fatto che questa ricostruzione del “giorno di Pasqua” contenga splendide immagini dell’epoca antica, del Medio Evo, Rinascimento, del Sei e Settecento, e che ci mostri poi opere di valore decisamente non paragonabile in lavori composti in età più vicina a noi. Occorrerà pur chiedersi, allora, come mai l’evento della resurrezione non abbia più potuto trovare degna rappresentazione nella contemporaneità.

Non, ovviamente, perché non esista più un’arte in grado di cimentarsi con la piccolezza e la grandezza dell’umano, con la straordinarietà di un evento. Ma perché altri linguaggi, come ha mostrato l’arte astratta, a partire dall’inizio del Novecento, si sono assunti la responsabilità di raffigurare la percezione dell’invisibile, di mostrare le complessità delle vicende terrene e lo sgomento delle piccole creature di fronte a ciò che non comprendono e al grande enigma che le avvolge. Per questo, credo, se è stato possibile dare forma alle immagini del Crocefisso (si pensi a Congdon, ma anche alle “pitture” di Salgado o agli scatti che ci mostrano le morti in mare e quelle degli umiliati e dei vinti della terra); per “rivelare” il miracolo delle rinascite quotidiane e l’immensità di ciò che ci sovrasta ci vogliono forse i fasci di luce dipinti da un Rothko (lui stesso ha chiamato alcuni suoi quadri “resurrezioni”) o il lampo di un gesto buono che contraddice i paesaggi del male, o un battito di stelle che giunge dall’ oscura immensità degli universi che ci circondano. Tanto più in questa Pasqua, che cade a oltre un anno dall’inizio di una pandemia che non mostra segni decisivi di recessione, occorre davvero prendere sul serio quelle esitazioni che le parole dei Vangeli e le interpretazioni dei secoli successivi non ci hanno nascosto. Dobbiamo liberarci dai veli delle mitologie, dalle pigrizie delle liturgie, dalle inerzie delle dottrine, e guardare alla nuda realtà di cui è fatta la nostra vita: un impasto di miseria e grandezza, in cui siamo chiamati ad avere pietà e responsabilità per il vivente, e l’unica attesa non è quella di un giorno radioso in cui il male sarà sconfitto e la luce trionferà sulle tenebre, ma la lenta, paziente fatica di costruire, di aver cura, di inventare strade nuove, di non smarrire per via l’obbligo verso ogni vivente. L’arte può dare corpo e forma a tutto questo. Questa è l’unica “rivelazione” che possiamo attendere.
.
Se continuiamo a tenere vivo questo spazio è grazie a te. Anche un solo euro per noi significa molto. Torna presto a leggerci e SOSTIENI DOPPIOZERO
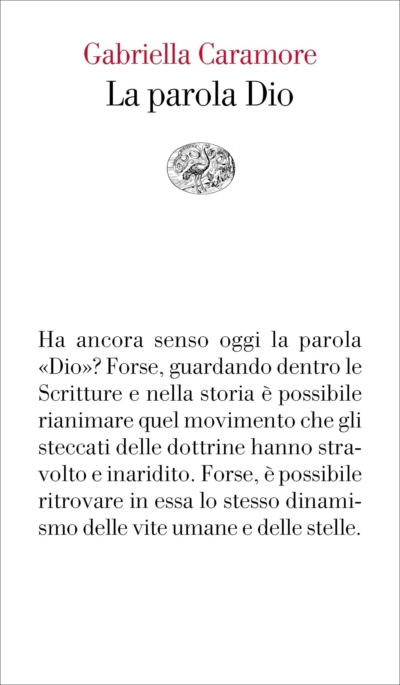
Dialogo su Dio
Doppiozero, 9 novembre, 2020
Con Gabriella Caramore e Romano Madera
“… Ho sempre considerato questo libro come un libro che si sta facendo, che non ha un punto conclusivo. Un libro provvisorio, in fieri. D’altronde, il pensiero su Dio è inevitabilmente un pensiero fluttuante, ondivago. L’importante è tenere desto il movimento del pensiero. Che cosa “diavolo” è oggi questa parola “Dio”, tu chiedi. È posta bene la questione. In primo luogo a me sembra che in questa fase della nostra storia sentiamo il bisogno di ridefinire tutto. Tutto quello che sta emergendo, la crisi del contemporaneo che stiamo vivendo, era già presente, evidentemente, sotto traccia. …”
Dialogo su Dio
Con Gabriella Caramore e Romano Madera
Romano Madera: La parola Dio: ma cosa “diavolo” intendiamo con questa parola? E soprattutto: oggi ha ancora un senso parlarne? Quale senso può avere nel nostro interrogarci oggi?
Gabriella Caramore: Tocchi il punto centrale. Ho sempre considerato questo libro come un libro che si sta facendo, che non ha un punto conclusivo. Un libro provvisorio, in fieri. D’altronde, il pensiero su Dio è inevitabilmente un pensiero fluttuante, ondivago. L’importante è tenere desto il movimento del pensiero. Che cosa “diavolo” è oggi questa parola “Dio”, tu chiedi. È posta bene la questione. In primo luogo a me sembra che in questa fase della nostra storia sentiamo il bisogno di ridefinire tutto. Tutto quello che sta emergendo, la crisi del contemporaneo che stiamo vivendo, era già presente, evidentemente, sotto traccia. Ma questo momento particolare, indotto dalla pandemia e dalle conseguenze economiche e strutturali del nostro sistema sociale, ha messo in luce i punti critici del nostro mondo e, insieme, la fatica che fa il linguaggio a stare dietro a queste crisi e alla nostra esigenza di capire. La domanda dunque è se in questa emergenza la parola “Dio” è una parola che ha ancora senso interrogare o se è parola che molti di noi ritengono superata, usurata, ridotta ai margini. Io credo che siano vere entrambe le cose, è vero che una grande parte di mondo – soprattutto del mondo occidentale, ma non solo ormai – non sente più il bisogno di parlare di Dio, ma è vero anche che le religioni esistono, sono numerose, numerosi gli appartenenti a ciascun credo: si fanno sentire, talvolta esercitano un potere, talaltra in forme aggressive e violente, altre volte sono portatrici di linguaggi sommessi e silenziosi, piccole realtà marginali. Di tutto questo dobbiamo tenere conto. Quando uno dice “Dio” sembra che ci si riferisca a qualcosa che appartiene a un linguaggio comune. Ma non è così. Intanto perché ha innumerevoli significati per ciascuna persona, ma, se guardiamo storicamente, per ciascuna religione, vediamo che sono innumerevoli i modi di intendere questa “parola”. Vi è qualcosa che noi occidentali chiamiamo “Dio” e che altri chiamano con altro nome. Basta pensare a quante modulazioni ha avuto la parola “Dio” dentro alla storia cristiana e al pensiero cristiano, quanti percorsi diversi, quante formulazioni. È chiaro, noi dobbiamo capirci dentro le formulazioni che il linguaggio offre, per cui diamo nomi “semplici” a cose più complesse dei nomi che le rappresentano. Ma oggi bisogna, forse, provare a decostruire quella che noi riteniamo un’ovvietà, provare a capire come è diventata un’ovvietà e se possiamo darle un contenuto un poco più complesso, come forse merita.
Quali strumenti abbiamo per fare questo? Abbiamo la conoscenza della storia: che va dalla complessità della figura del divino nell’ebraismo, alla visione del Dio cristiano, alla figura di Gesù di Nazaret, che è stato inteso come il figlio di Dio, il profeta, l’interprete dei profeti, alle piccole comunità che si sono costituite, all’adesione dei cristiani all’Impero, e poi via via nei secoli tantissime storie diverse all’interno delle quali ciascun credente si è situato in una maniera differente. Ci troviamo in una sorta di labirinto e cosa possiamo fare per non perderci in questo labirinto? Da un lato partire dalle Scritture, che sono state a lungo ignorate o mal comprese, o non abbastanza studiate all’interno della storia cristiana, dall’altro tener conto di come si è evoluta la storia. Adesso la situazione è più dinamica, ci sono tanti gruppi di studi biblici, ma non è sempre stato così, e se noi andiamo a vedere dentro le Scritture troviamo che il testo ci offre una mobilità infinitamente maggiore rispetto a quanto poi le comunità religiose hanno cercato di fare. Non dobbiamo essere moralisti e dire che le Chiese hanno rovinato tutto, dobbiamo capire che in gran parte gli errori sono stati compiuti per cercare di tenere coesa una comunità: per questo si sono stabiliti dei principi. Ma la vita scorre, passa, si trasforma. Spesso le comunità religiose hanno cercato di tenere ferma questa vita.
Se invece andiamo a guardare dentro le Scritture stesse troviamo una varietà e una mobilità di significati che non autorizza una staticità di interpretazione del nome di Dio, ma invece sollecita una ricerca del significato che generazioni e generazioni di credenti hanno voluto cercare per indicare qualcosa di enorme e incomprensibile che sta sopra, o al di là, delle vicende della vita umana.
Ci sono pagine molto belle a questo proposito nel tuo libro, pagine nelle quali si racconta cosa vuol dire Elohim, El Shadday, tutti i diversi nomi che il testo biblico usa per avvicinarsi a questo impronunciabile, a qualcosa che non è esaurito dai nomi. C’è un’altra cosa molto interessante che il libro suggerisce: “nessun timore a mettersi in cerca dei significati della parola ‘Dio’. Sapendo però che lo si deve fare con accortezza, mettendosi sulla scia di una tradizione, di maestri, di studi. Ma accordando un minuscolo credito anche al proprio personale sforzo di un incessante interrogare. Se i nomi di Dio sono tanti, questo accade perché, al fondo, vi è un nome nascosto che le nostre lingue non riescono a formulare, e che il pensiero arranca a voler definire. La stessa cosa si può dire delle immagini di Dio. Nessun Dio può essere visto. Forse non c’è neppure nessun Dio a cui sia sensato dare questo nome. Eppure tante sono le immagini che narrano Dio. Proprio per questo, come vi è un divieto relativo al pronunciare in maniera falsa e vana il nome di Dio, ve ne è uno, parallelo, che vieta di farsi immagini di Lui. Forse per proteggere la sua nascosta presenza in noi”. Tu, con questo elegante “minuscolo credito al proprio personale sforzo”, richiami a una lettura responsabile e critica.
Sì, dico “minuscolo credito” perché ovviamente non bisogna essere presuntuosi e credere di avere le chiavi di quel che si legge. La tradizione ci fornisce già abbondantemente innumerevoli strumenti di conoscenza. E tuttavia sta anche in ciascuno di noi la responsabilità di esprimere, anche silenziosamente, anche non clamorosamente, nel chiuso della propria stanza, il proprio pensiero o il proprio sentire – che poi sono la stessa cosa – su questa immagine di Dio. È una responsabilità perché nel nome di Dio sono stati compiuti i più efferati delitti e nel nome di Dio sono state compiute anche le azioni più belle. Forse un punto di partenza potrebbe essere cercare di capire che cosa ha tenuto insieme questa ricerca dell’umano, che cosa ha unificato nella storia umana questi cercatori di Dio, o, come li chiama André Neher, “i rabdomanti della luce”. Bisognerebbe andare a tentoni a cercare qualcosa, una piccola luce appunto, che possa illuminare il cammino. Da una parte potrebbero cadere le immagini troppo rigide di Dio che abbiamo ricevuto, e dall’altra potremmo ritrovare quei chiaroscuri intorno al nome di Dio che riflettono i chiaroscuri della vita. Le immagini che sono state date di Dio sono tantissime – Dio violento, che condanna, che consola, il Dio che solleva il povero dalla polvere, che abbatte i troni dei potenti –: a quale credere? I fondamentalisti di tutte le parti chiamano a sé l’immagine di Dio. Abbiamo visto in Francia una recrudescenza dell’islamismo violento e assassino, di fronte al quale non possiamo che piangere e manifestare la nostra protesta. Ma non dobbiamo dimenticare che c’è anche un fondamentalismo cristiano, forse in questo momento meno violento, ma che comunque sostiene il suprematismo bianco fomentatore di odio (per non parlare di come si è manifestato nei secoli passati). Allora è vero, mi sembra, che occorra guardare con responsabilità e cautela questa parola “Dio”, per capire come possa essere non di ostacolo, ma di soccorso al mondo.
Questo elemento del “soccorso al mondo”, così come la citazione insistita su “tirare giù i potenti dal trono” si tratta di citazioni dei profeti della Bibbia ebraica, e anche del Magnificat di Maria di Nazareth, straordinario testo profetico. Volevo leggere un pezzetto per far innamorare del libro anche l’orecchio; sono parole su Maria di Nazareth e Anna, la madre di Samuele, che citano a loro volta la Bibbia ebraica, e che si rifanno alla tradizione profetica, che è una grande riserva critica. Prima abbiamo parlato di una lettura critica con il minuscolo apporto nostro – e anche questo è molto biblico, Abramo è uno che discute con Dio – e ora abbiamo questa questione della passione profetica, che è quello che dal nome Dio possiamo ricavare per la nostra vita sulla terra: “Proviamo a considerare, invece, quella ‘passione’ del profeta che lo spinge a uscire dalla propria ritrosia con un atto di coraggio e di generosità: è evidente che i popoli precipitano verso la rovina se si corrompono, se si illudono di possedere una forza che non hanno, se non guardano con lungimiranza, e se non hanno dalla loro un senso della giustizia e del diritto. Il profeta non fa il ‘servo sciocco’ del potere. Osa dire quello che gli altri per viltà non dicono. Osa denunciare. Osa essere critico, non ossequioso, osa smascherare, non occultare. Questa è la verità che ci mostra, a cui dobbiamo prestare attenzione”.
Ai profeti mi sono appassionata forse anche a motivo del titolo della trasmissione, “Uomini e Profeti”, ma forse anche per la difficoltà che si incontra leggendoli. Vi si trovano prospettive che a prima vista sembrano inaccettabili per la contemporaneità. La pretesa di essere portavoce della parola del Signore, la pretesa di conoscere la verità, la visione punitiva delle colpe dei popoli, una visionarietà che oggi può apparire ingenua. Ma se noi proviamo a riconsiderarli, tradurli nel linguaggio del nostro tempo, vediamo che forse oggi la profezia ha molto da insegnarci. Innanzitutto il profeta è persona di coraggio, responsabilità, dedizione. Fa qualcosa che non è per sé stesso ma per la comunità, per il “popolo”. E ha il coraggio di contraddire i potenti, di rischiare la propria vita, anche se non ne avrebbe proprio voglia. Di questo ci parla oggi il profeta: della responsabilità. Allora sì, se facciamo uno sforzo per capire i testi profetici nel loro linguaggio simbolico, se possiamo leggere i profeti e ascoltare il loro linguaggio visionario, possiamo capire che quello che prevale è la responsabilità nei confronti della comunità. Il profeta, poi, per il fatto di annunciare la parola di Dio, dice la verità: anche la parola verità ci mette oggi in questione. Oggi sappiamo che la verità non ci appartiene, che non possiamo raggiungerla, che tra noi e la verità ci sono abissi di universi da sondare. Però c’è anche il coraggio della sincerità, e questo è già molto, è qualcosa che possiamo capire e fare nostro. Inoltre, anche dire la visione implica coraggio.
Può sembrare una favoletta quella del lupo che pascolerà con l’agnello e le spade trasformate in aratri. Però è una possibilità nella vita degli esseri umani, rovesciare le visioni correnti è una possibilità che è stata data qui e là nella storia. Ecco allora che l’utopia può farsi progetto: non ci arriveremo, ma possono aprirsi piccoli varchi in cui qualche cosa sia realizzabile. Un altro elemento che dobbiamo oggi interpretare è il fatto che il profeta lavora per il “popolo”: è chiaro che oggi noi non possiamo più guardare a un unico popolo come destinatario di una parola di Dio, ammesso che possiamo parlare di Dio in questi termini. Oggi siamo tenuti a guardare a un’universalità dei popoli. Ma appunto, se invece di “popolo” consideriamo la comunità di viventi, e questo possiamo farlo, perché nei profeti troviamo questo allargamento, possiamo assumere tutta la forza, la dirompenza, il coraggio, la visionarietà dei profeti e tradurla in termini contemporanei. Questo mi pare un possibile uso delle Scritture che in gran parte sono invece state imbrigliate dentro norme morali, regole di vita, catechismi, principi di autorità.
Tu infatti parli della grande utopia: questo rapporto tra il profetismo e la possibilità visionaria, utopia non come qualcosa da realizzare nell’immediato – altrimenti si fanno disastri – ma come orientamento, criterio. E tornando alla questione della parola “Dio”, c’è un fatto indiscutibile, che “Dio” è una parola. Ma che razza di realtà si può pensare per questa parola? Le parole producono fatti, trasformazioni, e dunque mi pare che nell’insieme del libro – e il libro finisce così – ci sia un’idea forte che lo attraversa: Dio ha tanti nomi ma in fondo è un nome impronunciabile. Il libro si chiude in un nome che non ha nome. E questo lo diceva anche un grande mistico cristiano, cattolico, moderno: Thomas Merton. Diceva che il nome di Dio è x. La tua idea è di far vedere che se rovesciamo il modo con cui abbiamo chiamato in tanti modi Dio, otteniamo qualcosa che forse ci dice di più sulla realtà della parola. E cioè: Dio è giustizia, Dio è misericordia, Dio è amore, Dio è insieme. Rovesciamo, piuttosto: la misericordia è Dio, l’amore è Dio, il bene è Dio, il mistero è Dio. Il mistero è un nome che non ha nome. Tutto questo possiamo rapportarlo a qualcosa che ci riguarda intimamente, come suggeriscono queste parole del tuo libro: “Certamente c’è una domanda di salvezza che non è comprimibile. Chi è nel dolore o nel bisogno estremo invoca una risposta. Che venga da Dio o da un essere umano non sta qui la differenza. Chiunque ci tragga in salvo, per un momento, è Dio. Talvolta la salvezza viene. E rinasce il giorno. Altre volte la risposta non arriva, arriva solo il silenzio e la sconfitta. Ed è notte e fine di ogni cosa”. Tra l’altro per coloro che si riferiscono al cristianesimo, è interessante ricordare che Gesù vuol dire Dio salva, il significato è: chi ti porta salvezza? Questo è Dio.
Nel caso di Gesù: chi ti porta salvezza? Questo è un uomo. Un uomo che ti viene incontro e dunque lì, in quella umanità che si fa incontro, può stare la salvezza. Io credo che questo rovesciamento sia anche qualcosa di semplice da pensare. Se si continua a parlare di Dio come un soggetto, se si continua a dire che “Dio è giustizia”, “Dio è misericordia”, “Dio è amore”, in fondo lo si rende un oggetto dei nostri pensieri, dei nostri credo, delle nostre illusioni. Ne facciamo un “complemento oggetto”, qualcosa di astratto che non parla più ai cuori e alle menti di noi contemporanei. Se invece rovesciamo la prospettiva, e proviamo a dire che a quel bisogno insopprimibile di giustizia gli esseri umani hanno provato a dare un nome grande, un nome fuori dal comune, un nome quasi irraggiungibile ma necessario che è il nome di Dio; se quel bisogno essenziale per la vita comune che è la misericordia, cioè gettare il cuore dalla parte degli infelici (Bonhoeffer diceva che, in fondo il cristianesimo è un guardare il mondo a partire dal basso) le generazioni lo hanno chiamato “Dio”; se per quell’amore che è più grande di ogni altro amore è stata usata la parola “Dio” – allora possiamo. Questo nome rimane perché ha dato corpo, ha dato visione, a queste esigenze insopprimibili dell’essere umano – giustizia, amore, libertà – che hanno poi assunto diverse forme nella storia ma che qualcuno ha chiamato con il nome più grande, con il nome di Dio.
Volevo farti commentare un inizio e una fine del libro che ritornano su questo punto ma in un modo tanto concettuale quanto narrativo. Il libro si apre raccontando un episodio che fa parte di frammenti autobiografici di Martin Buber. Buber si trova con un vecchio professore e gli legge un testo e in questo testo, alla fine della lettura, “il professore, sul cui volto si dipingeva un crescente stupore – gli occhi ardenti, la voce alterata –, chiede a Buber: ‘Come fa a ripetere tante volte la parola Dio’?”. Ci sono qui righe strepitose di Buber, una meravigliosa apologia della parola Dio, e il commento della Caramore è “si può ancora pronunciare la parola ‘Dio’ dandole un significato che vada al di là di una inerte sopravvivenza?”.
Alla fine del libro ritorna questo episodio e qui il commento è “ma nel momento dell’invocazione forse è legittimo pensare a un azzeramento di ogni memoria storica, all’assottigliamento del nome invocato, fino a dissolversi in un nome che non ha nome. Del resto, questa instabilità del nome non era suggerita anche nei testi della tradizione? Inoltre, Buber stesso ci viene in soccorso con le parole che chiudono il suo racconto: ‘La stanza si era fatta molto chiara. La luce non fluiva più: c’era. L’anziano signore si alzò, mi si avvicinò e pose la mano sulla mia spalla dicendo: vogliamo darci del tu? Il colloquio era finito. Poiché dove due persone sono veramente insieme, lo sono nel nome di Dio’. Noi potremmo provare a riprendere il pensiero di Buber e dell’anziano professore, cercando di non tradirlo, ma considerandolo, un secolo dopo, dal nostro punto prospettico appena in parte trasformato. Quando due persone riescono a incontrarsi in maniera profonda e vera, e si riconoscono l’una nel volto dell’altra come esseri umani facenti parte di una stessa avventura, comprendono che ogni itinerario terrestre va considerato alla luce di qualcosa di più grande della singolarità dell’individuo. Va considerato alla luce di quella parola, ‘insieme’, dentro la quale si snodano i percorsi delle vite umane, che non possono prescindere le une dalle altre. E che neppure possono prescindere dal sentirsi avvolte dall’immenso silenzio dei mondi sconosciuti. Ecco forse a questo essere ‘insieme’ si può anche dare il nome ‘Dio’.”
Sì, si potrebbe anche dire il contrario di quello che dico chiudendo il libro, forse quel “nome di Dio” con cui chiude Buber si potrebbe anche tradurre nell’essere “insieme” degli esseri umani. Questo essere un “tu” l’uno per l’altro è fondamentale nel pensiero di Martin Buber. Ma questo essere “insieme” di tue “tu” forse rende anche inessenziale il ricorso al nome di Dio. Ma qui si può aprire anche un altro discorso. Gran parte del percorso di questo libro è volto a considerare l’aspetto umano delle dimensioni che portano a elaborare qualcosa a cui viene dato il nome di Dio. Ma “Dio” è il nome che è stato dato anche a ciò che non conosciamo, all’inconoscibile verso cui tendiamo, a quell’anelito di ricerca che muove al desiderio di sapere, di uscire fuori da sé e dai propri confini per andare verso un altro che rimane enigma e mistero. Mi soccorre sempre il pensiero di Pascal e del suo sgomento di fronte ai cieli stellati. Oggi i nostri cieli stellati sono più profondi, più lontani, man mano che la ricerca scopre nuove dimensioni del reale per paradosso il nostro conoscere si fa più incerto. Possiamo continuare a dare il nome di Dio anche a tutto questo? Forse. Soprattutto possiamo capire che quando leggiamo i testi che lo nominano, che lo invocano, che lo maledicono, che gli rendono grazie non è a qualcosa di vuoto che si riferiscono, ma a una appassionata ricerca di un senso nelle vite dei mortali. In questo ripensamento del nome di Dio si possono ricongiungere le due dimensioni: quella volta all’umano e quella volta al desiderio di conoscenza della vastità in cui siamo immersi.
Su questo vorrei fare due osservazioni: le belle pagine a proposito del sentimento oceanico, o sentimento dell’immenso; tra queste pagine quelle sulla considerazione contemplativa da parte di una grande fisico. “Heisenberg, ancora ragazzo, già appassionato di fisica e di filosofia, una sera del 1919, a guerra mondiale da poco finita, si ritrovò nel castello di Prunn, in Baviera, con altri giovani studenti, a discutere dell’avvenire della scienza, travolto quasi suo malgrado dalle nuove scoperte e dai nuovi linguaggi. Il giovane Heisenberg è stanco, confuso, scoraggiato dalla percezione dell’assenza di un ‘ordine globale’. Ma ecco ‘nel grande cortile del castello le ombre si allungano, scese la luce grigia del crepuscolo e poi la notte rischiarata dalla luna. A questo punto, su una balconata, apparve un ragazzo con un violino. Si fece silenzio e risuonarono i primi grandi accordi in re minore della Ciaccona di Bach. Di colpo, con assoluta certezza, seppi di aver trovato il collegamento con quel centro che mi mancava. Il limpido fraseggio della Ciaccona spazzava via le nebbie mostrandomi le gigantesche strutture che fino ad allora mi erano rimaste nascoste’. Chi potrebbe dire che la Ciaccona di Bach, ascoltata in quella particolare congiuntura, non fosse una preghiera?”. E a questo volevo aggiungere una cosa a proposito della questione dell’inconoscibilità, del mistero, una considerazione di un grande teologo cattolico, Karl Rahner che, nel primo capitolo del Trattato sulla Fede, dice una cosa semplice e geniale, una cosa che rimette in rapporto tutta la modernità, lo sviluppo della scienza, con il problema Dio. Mi sembra che sia qualcosa abbastanza vicino a quello che dici tu e al sentimento di Heisenberg. Rahner teorizza una conoscenza atematica di Dio, una conoscenza che non si può costringere in un detto, in un nome, in un concetto, che non si può mettere a tema, “e, da questo punto di vista, siccome la conoscenza più si approfondisce più si approfondisce il mistero” – sia nell’infinitamente piccolo che nell’infinitamente grande – “il progredire della conoscenza aumenta il mistero”. Mi sembra che così un percorso teologico si accosti anche alla nostra percezione del cosmo, ovviamente influenzata dalla scienza contemporanea e possa accordarsi perfettamente con il progredire delle stesse conoscenze scientifiche.
Intanto voglio dire che ogni volta che leggo le parole di Heisenberg mi vengono i brividi. Sono di una tale bellezza, pensando poi al dramma che ne è seguito. Pensare a questo ragazzo che ascolta questa musica che arriva per caso nella notte e capisce cosa gli manca, di cosa è in cerca. Quanto a Rahner: quando si arriva a una conoscenza atematica di Dio forse non c’è neppure più bisogno di metterlo a tema, forse dobbiamo trovare altri nomi, tenuto ovviamente conto della molteplicità della nostra realtà, delle comunità dei credenti, delle Chiese. Però, a un altro livello, forse possiamo dire che non c’è più bisogno di mettere a tema Dio, ma di mettere a tema la conoscenza, il nostro slancio verso il desiderio di conoscere. In questo senso la musica, la poesia, sono tutte espressioni che forse non possono essere dette atematiche ma che non hanno un confine delimitato, aprono a qualcosa che non si può dire, all’indicibile, appunto. Come Dio. Certo, sono dimensioni parallele che non possono essere unificate: da un lato uno slancio verso quel che non possiamo conoscere ma non possiamo non desiderare di conoscere, e dall’altro una dimensione prettamente umana in cui c’è bisogno di libertà, giustizia e misericordia. Mettere insieme queste due cose io credo sia la scommessa più difficile ma anche la scommessa che dobbiamo giocarci, perché la religione entra nei vissuti minuti, nel quotidiano delle persone, ma è necessario tenere aperta la porta verso il mistero, altrimenti ci richiudiamo dentro e crediamo di avere la soluzione per tutto.
A questo proposito la valenza concreta nelle nostre vite è un’altra declinazione, ma forse la declinazione che può raccoglierle quasi tutte, se non tutte, di ciò che ha a che fare con il senso. Cito due cose. “Sia chi conserva la fede, sia chi se ne sente distante dovrà inevitabilmente vagliare al setaccio del tempo ciò che oggi non si può neppure ascoltare. Ma potrà farlo con serenità. Sapendo che ciò che oggi intendiamo con giustizia, misericordia, pace, verità e libertà ha la sua culla anche e proprio in quelle preghiere. Il lettore contemporaneo, poi, farà fatica a pensare che quegli esseri in preghiera si attendano veramente che le loro invocazioni vengano esaudite. Oggi ci vorrebbero anime antiche per avere la certezza di essere ascoltati. E tuttavia credo che, al fondo, si possa dire che il senso più nascosto della preghiera, nascosto come in una nube, non sia quello di attendersi la risoluzione dei propri drammi o problemi, ma la speranza di comprendere a fondo quale sia il sentiero da percorrere nella vita”. Mi permetto un breve commento: i due termini ebraici per dire “peccato” si possono tradurre con “sbagliare la strada, non colpire l’obiettivo”, non trovare il sentiero giusto da percorrere nella vita. E infatti scrive Caramore citando Heschel “questo ci permette di chiarire che cosa è essenziale e che cosa non lo è per ciascuno di noi. Certamente per Heschel Dio non è un nome, ma una realtà. Solo quando quel nome è vissuto come realtà, e non come proiezione idolatrica della mente – penso si possa dire così –, esso orienta le vite verso il bene”. Il mio accento cade su “orienta” e su “il sentiero da percorrere nella vita”: potremmo dire allora che il problema di Dio o non Dio – possiamo chiamarlo come ci pare – è che non possiamo evitare il problema buttando via la parola. Dio o non Dio, il problema è: quale è il sentiero da percorrere nella vita? E questo ci accomuna tutti. Solo per questo vale la pena interrogarsi. In qualche modo la parola Dio credo che contenga in modo eminente, nella storia dell’umanità, questo problema.
Sì. Il sentiero da percorrere nella vita. Qui torniamo all’elemento della libertà e del rischio. Nessuno ce lo dice, neppure i comandamenti ce lo dicono, sono indicatori di cammino dentro cui ci può stare di tutto. Cito un detto dei Padri antichi della tradizione rabbinica che dice “non sta a te compiere l’opera, ma non sei libero di sottrartene”. Figuriamoci se tu, piccolo essere umano, puoi arrivare al compimento di un’opera, però hai la responsabilità di fare fino in fondo tutto quello che puoi fare.
Ci sono appartenenze, ciascuno si ritrova nella sua storia e nella sua tradizione, ma forse non si tratta nemmeno più di costruire il dialogo tra le religioni, anche perché una religione è un insieme di tali tante e diverse identità che forse il nodo deve esser spostato. Ciascuno lavori dentro la dimensione in cui gli accade di vivere, con il proprio bagaglio culturale e umano, ma il problema è cercare un minimo comune denominatore di tutta l’umanità: cosa sono i diritti, cosa i doveri, quale è il compito verso l’umanità – come avrebbe detto Simone Weil che non amava il binomio diritti doveri perché troppo burocratico. Ognuno deve portare il proprio contributo, c’è un compito che abbiamo verso ogni essere umano, un compito che è dare pane, casa, cibo, bellezza, conoscenza, libertà, dignità. Lavorare su questi. È utopia? Certo, ma non siamo liberi di sottrarcene. Poi vanno bene le preghiere, il dialogo inter religioso, ma ho l’impressione che a volte questi siano contenitori, certo contenitori più sani dell’inimicizia, ma non è dentro questi nomi che troviamo il momento unificante. Il momento unificante si trova in basso, partendo dalla comune umanità che viviamo, e allargherei questa umanità al vivente, al rispetto per gli animali, per le piante, per la terra.
Se continuiamo a tenere vivo questo spazio è grazie a te. Anche un solo euro per noi significa molto. Torna presto a leggerci e SOSTIENI DOPPIOZERO
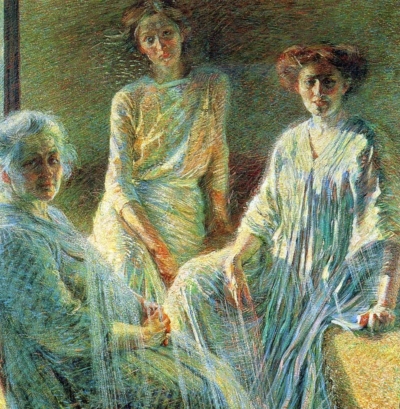
Umberto Boccioni
Tre donne (1909-1910)
Il tempo ultimo
Doppiozero, 18 ottobre, 2020
Gabriella Caramore
“… Perché ho scelto questo tema come oggetto dei pensieri intorno alla cura? Forse semplicemente perché la fase ultima della vita umana è un tempo che ha bisogno di cura come ne ha bisogno l’infanzia, si potrebbe dire. Ma forse anche, inutile nasconderlo, per una necessità autobiografica. Essendo entrata in una fase della vita che non può più nascondersi l’avvicinarsi della scadenza ultima, sono in parte sgomenta, in parte incuriosita dal fatto che considero le cose in maniera diversa da come le consideravo prima….”
Il tempo ultimo
La cura come pensiero
“Cura” è una parola che sta risuonando insistentemente nelle iniziative pubbliche, nei discorsi comuni, negli incontri degli ultimi mesi. Come se ci fosse una urgenza, una fretta, una necessità di comprendere, al di là della pandemia che ha colpito il mondo, quale sia la malattia più profonda che si è insinuata in tutte le fibre del pianeta, e che ha messo in evidenza non solo la fragilità della vita umana, ma la criticità di tutto il sistema di vita sulla terra, e i rischi, forse per la prima volta davvero “fatali”, che stiamo correndo. E, di conseguenza, come se fosse imprescindibile individuare e esercitare una cura.
Ma, appunto, su molte, troppe ferite occorre apprestare le cure. È l’intero nostro mondo che appare malato. Di quali e quante malattie? Quali sono i sintomi, quali le diagnosi? Quali procedure, quali farmaci andranno usati per le tante patologie del pianeta? Per ottenere che cosa? Guarigione? E con quali aspettative? E se si trattasse di una malattia “terminale”? Non tutto si può sempre curare. L’esito può essere anche letale. Ma è possibile curare anche la morte? O questa è una domanda priva di senso? La risposta sembrerebbe ovvia. È la vita che si deve curare, perché anche la morte abbia un senso. Chi ha in mano le sorti del mondo non sembra, purtroppo, dare gran peso a questo pericolo. Ma noi sappiamo anche che silenziosamente, senza clamore, in tanti angoli del mondo esiste una società civile che reclama a gran voce una cura del vivente. In tanti piccoli luoghi nascosti esistono uomini, donne, gruppi di persone che hanno a cuore la cura dei viventi e del mondo, che mettono in atto progetti, che agiscono per ricomporre ferite, per dare guarigione alle offese. È lì, in quelle piccole porzione di spazio a disposizione di ciascuno che tutti noi dovremmo accendere il nostro esercizio di cura. La cura presuppone uno spazio e un tempo. Piccoli spazi che si dilatano. Porzioni di tempo che si espandono. Ma sono sufficienti queste minuscole “isole di fraternità” a salvare il mondo malato? No. Il mondo non sarà mai salvato né redento. Non è prevista redenzione per il mondo. Quello che si può fare è aprire varchi di guarigione nella compattezza della malattia. Si può procurare sollievo. Si possono dischiudere possibilità.
Per fare questo però è necessario provare a fare un salto di qualità relativamente all’idea di cura. E capire che non basta pensare la cura semplicemente come il gesto di riparazione di un singolo guasto, un farmaco che faccia scomparire un sintomo, ma piuttosto come un radicale orientamento di pensiero, l’esigenza di un modo diverso di stare al mondo. Occorre studiare con più disincanto la gravità dei mali che affliggono il pianeta, capirne le connessioni, avvertire l’urgenza di correre ai ripari, mettere in atto non solo una sorta di terapia salvavita – ammesso che non sia troppo tardi –, ma anche elaborare una strategia di cura all’interno di un dinamismo del pensiero, di una eccedenza della disposizione di ciascuno verso l’altro e verso il mondo. La cura deve poggiare sì sull’onda emotiva che spinge a sporgersi verso l’altro, ma ha anche bisogno di prendere atto della complessità dell’esistente. Ha bisogno di intelligenza, di immaginazione, di azzardo. Perciò sono necessarie le forze di tutti, le competenze di tutti, l’inventiva di tutti. Avere cura significa certamente rispondere con moto immediato del cuore verso chi è nel bisogno o nella difficoltà, ma anche formulare pensieri intorno all’idea di cura. Dal gesto circoscritto del curare occorre passare all’azione, espansa nella durata, dell’aver cura.
In questo senso l’emergenza che abbiamo vissuto – e che stiamo vivendo – scaturita dalla diffusione del Covid-19 ha avuto un risvolto “positivo”, a patto che si facciano oggetto di pensiero, appunto, i segnali che sono emersi per intervenire in senso autenticamente terapeutico. L’irruzione del virus in tutti i paesi della terra ha letteralmente scoperchiato i diversi pericoli in cui incorre il pianeta, quelli antichi e quelli nuovi, in maniera drammatica. Ha messo in luce non solo l’emergenza sanitaria – causata certo dall’improvviso insorgere del virus, ma anche dal fatto che non se ne sono volute leggere le prevedibili avvisaglie e che tutto un sistema di incongrue priorità aveva smantellato la possibilità di farvi fronte –, ma anche l’emergenza economica e sociale radicata delle drammatiche diseguaglianze che hanno messo al tappeto le economie più fragili; ha reso più palese il rischio che sta correndo l’intero pianeta di trasformarsi in un globo non più adatto al proliferare dei viventi, con il depauperamento intensivo e sconsiderato delle risorse del suolo, con le deforestazioni, gli incendi, la cementificazione, l’inquinamento selvaggio, lo sfruttamento crudele e dannoso delle vite animali e di quelle vegetali. Certamente tutto questo non è solo responsabilità umana. Altre forze agiscono nel cosmo. Ma certo è tragicamente incongruo che non si mettano in atto tutte le risorse possibili per riparare almeno i danni che dipendono dal comportamento umano.
Ma l’emergenza sanitaria ha anche messo a nudo, in maniera più vistosa che mai, una crisi di umanità a cui bisogna tentare di dare almeno qualche risposta. Dove sta la particolarità dell’umano, se non in un senso di responsabilità, di intelligenza, di creatività, di cura, appunto? Le atrocità cui assistiamo – guerre, violenze, razzismo, soprusi, inganni, avidità – ovviamente non sono nuove sotto il sole. La storia umana è sempre stata costellata da efferatezze di ogni tipo. Da guerre sanguinose e brutali, da saccheggi, da inferni inflitti ai deboli e ai vinti, da discriminazioni, da angherie, da malvagità di ogni tipo. Certo, è vero che il bene che gli esseri umani si sono voluti, le cose belle che hanno costruito, scoperto, creato, amato, sempre hanno contraddetto il male dilagante sulla superficie del mondo, ne hanno incrinato il dominio altrimenti assoluto. Oggi però lo scandalo è, in qualche misura, qualitativamente più grave. Il fatto che obbrobri e ignominie continuino, a questo punto della storia, a sfregiare la comunità dei viventi e l’habitat che la contiene è tanto più vergognoso in quanto molti strumenti sono stati elaborati per dimostrare quanto improduttivi, oltre che nocivi, siano egoismi identitari, discriminazioni razziste, ingiustizie economiche e sociali, manifestazioni di odio, censure, strapoteri, tirannidi. C’è una Carta dei diritti dell’uomo che dovrebbe sancire di fatto, oltre che di diritto, l’uguaglianza degli esseri umani; c’è una Organizzazione delle Nazioni Unite che dovrebbe placare i focolai di guerra; c’è una Organizzazione mondiale della sanità che dovrebbe regolamentare la cura – ovunque – delle malattie che affliggono i corpi e le anime. Ci sono tanti altri strumenti che dovrebbero offrire pace, benessere, giustizia, benevolenza. Ma è come se ci fosse un bisogno di efferatezza, di bestialità, di predazione che non si placa, e che anzi torna a ruggire, a lacerare, a distruggere. C’è una fame di potere, una sete di odio che non si acquietano mai.
Che fare allora? Provare a guardare, poco per volta, schegge della nostra esistenza, per considerare se sia possibile, qua e là, mettere in atto strategie di cura che possano smentire l’ineluttabilità di una deriva senza ritorno. Tanto più, allora, “cura” significa non soltanto far fronte all’emergenza, ma elaborare pensieri, fare profezie, scegliere le priorità, orientare le abitudini, studiare, soccorrere, aiutare. Senza timore, possibilmente, di guardare in faccia anche ciò che forse non si vorrebbe guardare.
Il tempo ultimo
Perché ho scelto questo tema come oggetto dei pensieri intorno alla cura? Forse semplicemente perché la fase ultima della vita umana è un tempo che ha bisogno di cura come ne ha bisogno l’infanzia, si potrebbe dire. Ma forse anche, inutile nasconderlo, per una necessità autobiografica. Essendo entrata in una fase della vita che non può più nascondersi l’avvicinarsi della scadenza ultima, sono in parte sgomenta, in parte incuriosita dal fatto che considero le cose in maniera diversa da come le consideravo prima. Mi accorgo di aver spostato impercettibilmente la mia attenzione su oggetti che prima mi apparivano lontani. E mi interrogo, come è naturale che sia, sul senso di questa nostra vita umana che svanisce; su come la sto vivendo e su come la vedo vivere da chi si trova nella mia stessa condizione, o magari un po’ più vicino di me al passaggio definitivo. E ancora mi interrogo su come un essere umano può affrontare la sparizione degli affetti più cari, così, d’un tratto, dall’orizzonte che ha sempre circondato la sua vita. E sul senso di quella grande ecatombe di tutte quelle persone che si vedono dileguarsi intorno a noi, quel loro diventare ombre, restando nello stesso tempo presenze. Mi interrogo anche – magari vanamente – su come vivrò, eventualmente, il tempo che precede l’uscita definitiva dal mondo e su come vivrò, se mi sarà dato, quella che sarà davvero l’ultima soglia, e mi chiedo se sarà davvero possibile entrarvi “ad occhi aperti”, o nello strazio del dolore o nell’ottundimento indotto dai farmaci. Se sarò sola, o ci sarà qualcuno con me. E mi chiedo anche, senza riuscire a darmi risposte, quale sia il senso, ammesso che ve ne possa essere uno, delle morti precoci, di quelle improvvise, di quelle violente: quelle vite che finiscono senza neppure aver avuto il tempo di saperlo. Ma anche sulle vite che troppo a lungo si trascinano.

Opera di Andrew Wyeth.
L’immagine del “tempo ultimo” evoca anche, inevitabilmente, un’eco del linguaggio religioso, così come si è sviluppato nei secoli in Occidente. Il “tempo ultimo” – il tempo escatologico, delle “cose ultime” – era una sorta di prospettiva cosmica e definitiva alla quale era necessario tendere, per porre riparo alla precarietà del tempo vissuto sulla terra. Quando lo scorrere del tempo cronologico si sarebbe concluso, saremmo entrati nel “mondo che verrà”, in un “altro regno”, nella “pienezza dei tempi”, in un trionfo di luce e di gloria. Presupponendo, certo, che “le cose di prima sarebbero passate”. Oggi evidentemente questo immaginario non fa più presa sulle nostre menti e sulle nostre coscienze, neppure – mi permetto di dire – su quelle dei credenti. La nostra percezione del tempo si è raccorciata. È come se fiutassimo un pericolo, come se sentissimo il brivido che percorre questa nostra terra senza più prospettive per il futuro, senza avvertire quel senso di proroga indefinita che le religioni ci promettevano. In questo ci sollecitano anche le ipotesi scientifiche che forse per la prima volta prospettano una sorta di autodistruzione del pianeta. È per questo, credo, che anche il tempo ultimo delle nostre vite si colora oggi di tonalità diverse.
A fronte di queste visioni della fine, mi soccorre spesso il pensiero di Hannah Arendt secondo cui “Tutti gli esseri umani devono morire. Ma gli esseri umani non sono nati per morire, ma per incominciare”. Una visione piena di coraggio, tutta piegata verso la “vita attiva”. Ritengo tuttavia che occorra però anche guardare in faccia la fine che tutti ci attende. Sì, siamo fatti per incominciare. Ma siamo fatti anche per finire. Ma quella fine deve poter essere considerata, indagata se non si vuole privare la vita umana di una parte essenziale del suo percorso, come se il tempo ultimo fosse un arto amputato da gettare via. Senza ossessione, naturalmente. È naturale che la gran parte della vita la trascorriamo pensando alla vita stessa. Sarebbe patologico il contrario. Eppure, anche l’ultimo tratto di strada deve essere percorso con l’attenzione, e la cura, che si deve a quelli precedenti. Proprio la sua fragilità ce lo chiede. E anche quell’imperscrutabile evento che è la morte stessa.
Una civiltà che trascura di pensare la mortalità, e che non ne ha cura, è una civiltà che prima o poi si guasta, si deteriora, va a male: letteralmente “va verso il male”. Ricordiamoci che la storia delle civiltà comincia non con la pura sopravvivenza – questo lo sanno fare molto bene anche gli altri esseri viventi, gli animali, le piante –, ma con l’elaborazione dei riti funebri, con i racconti di vita vissuta, con l’invenzione della trascendenza. In una parola con la “cura” della dimensione umana. Se ci pensiamo, sono tutte cose superflue alla sopravvivenza, ma necessarie a fare comunità umana. A questo “serve” aver cura. A costruire umanità, a correggere la distruttiva “incuria”.
Ma, appunto, anche il tempo ultimo della nostra vita si presenta in forme diverse. Non solo perché innumerevoli sono le modalità delle esistenze. Ma perché c’è il tempo dell’anzianità, il tempo della vecchiaia estrema, il tempo del morire … Si può anche dire che un conto è la morte nostra, un conto quella degli altri che ci sono cari, un altro ancora quella dei lontani. Però penso anche che la morte è una. Quella degli altri è profezia della nostra. E viceversa. Piuttosto, se vogliamo indagare – anche superficialmente – i significati del tempo ultimo della vita, e della necessità di predisporre una cura per esso, penso che dobbiamo guardare al diverso scorrere dei giorni nelle fasi in cui ci si approssima alla fine. È evidente che ogni classificazione sarebbe puramente approssimativa e provvisoria. Tuttavia possiamo tentare di individuare almeno due “passi” dentro i quali tenere le diverse fasi che ci accompagnano nel tempo ultimo. Il primo è quello di un tempo che possiamo chiamare “penultimo”: quello che ha ancora un futuro davanti a sé, il cui orizzonte è raccorciato ma non sparito, quello in cui il soggetto stesso è ancora attore della sua recita nel mondo, e deve farsi anche portatore di cura per gli altri e per sé. Il secondo è quello della “soglia”, che non ha più né futuro né passato, e in cui anche il presente è un grande vuoto che ci interroga.
Fra questi due, un “passo immobile”, una sorta di “tempo senza tempo” che è la vecchiaia estrema, l’agonia, lo spegnimento della coscienza, l’attesa, nei confronti del quale la cura deve essere vigile e non pavida, libera e non imbrigliata nelle convenzioni della modernità. Soprattutto generosa, intelligente, pietosa.
Tempo penultimo
È quello in cui una vita che si possa chiamare tale è ancora possibile. Anzi, forse è il tempo di una vita più piena, in cui la coscienza non solo è vigile, ma affina i sentimenti, aiuta l’intelligenza a essere più selettiva, favorisce la pazienza nei confronti del prossimo, stempera i giudizi, accoglie una visione più ampia della storia del mondo. È anche il tempo della malinconia, di qualche rimpianto, dell’affiorare di qualche rimorso, di una considerazione amara delle vicende umane. “Ho visto tutte le cose che si fanno sotto il sole, ed ecco tutto è vanità e un inseguire il vento …” afferma Qohelet nel suo tedio sapiente (1,14). Ma è l’età in cui ancora tutto, o quasi, è possibile. Sì, il corpo mostra segnali di indebolimento, lo vediamo tutti che c’è sempre più bisogno di ricorrere ai medici, agli ospedali, alle analisi di laboratorio. Il corpo si sgretola prima qua, poi là, poi si aggiunge un acciacco, poi si tampona una carenza, se ne apre un’altra, e così via.
Ma la vita c’è ancora. Ed è ancora vita piena se ci sono affetti, famiglia, relazioni, incontri. Se c’è musica. Lettura. Teatro. Bicicletta. Passeggiate. Qualunque tipo di lavoro. Godere la propria casa. Cucinare, conversare, coltivare fiori, conoscere paesaggi, respirare vapori di mare, profumo di monti. Tutto un pochino più faticoso, è vero. Ma la fatica è anche soggettiva. Ci sono gli eterni stanchi. E gli eterni infaticabili. E poi fatica significa esser vivi.
In questa fase della vita che cosa fa la differenza tra un vecchio e un altro? O – se la parola vecchiaia disturba – tra un anziano e un altro?
Il luogo in cui si è nati e si vive. In altre parti del mondo i vecchi vivono (vivevano fino a poco tempo fa) all’interno di famiglie numerose, dove erano ancora ascoltati per la loro saggezza, ma dove anche erano curati alla bell’e meglio, certo senza tutte le accortezze di cui, per lo più, si gode in Occidente, e sicuramente senza tutti quei privilegi di agio, di libertà, di autonomia che il vecchio nel nostro mondo si è conquistato.
Gli affetti fanno la differenza più grande. Chi è solo intristisce prima, smette di interagire, impigrisce cuore e cervello. I suoi giorni sono più freddi. Le notti più disperate. Anticipa rapidamente la morte in vita. Affiorano rancori, rabbie, rivalse. Allontana da sé anche chi vorrebbe aiutarlo.
Le strutture mediche di cui si dispone. Certamente in un villaggio dell’Africa, dove manca l’acqua, dove c’è un ospedale raggiungibile a decine o centinaia di chilometri, dove mancano le strutture elementari di igiene e di assistenza, si viene curati con più approssimazione rispetto a un ospedale occidentale. È vero però che alcuni ospedali dei paesi più poveri consentono una dimensione più umana, facendo accudire il malato anche dai familiari, con i bambini che giocano intorno. Condizioni igieniche più precarie, ma meno desolazione affettiva. E d’altronde ricordiamoci nella civilissima Svezia – se ne è parlato poco – nel periodo dell’emergenza sanitaria, è stata stilata una lista delle priorità nell’assistenza ai malati, una specie di classifica, o di ordine di importanza: vecchi e handicappati occupavano l’ultimo posto. Nessuna cura, o una cura minima, che vuol dire lasciarli morire. Per le proteste di molte associazioni la cosa è poi rientrata. Ma quella lista esprime una visione corrente che vede la vecchiaia, o l’handicap, come disvalore, e quel tempo penultimo come un tempo senza importanza, una appendice residuale all’umana esistenza.
Il reddito e la cultura. Non esser poveri significa moltissimo. Abitare una casa e non una baracca o un angolo di strada fa una differenza assoluta. Casa significa ambiente, memoria, ricordi, uno spazio familiare, un luogo dove si respira. “Aria di casa” si dice per indicare un odore conosciuto e confortevole. Reddito, poi, significa sicurezza, non ammalarsi di ansia e di paura, poter avere accesso ai beni necessari, agli aiuti, ai piccoli piaceri, poter scegliere un andamento dei propri giorni. Non è necessario ipotizzare una vecchiaia satura di consumismo e di ricchezza. È sufficiente, per poterne godere, poter aiutare figli e nipoti, essere generosi con chi ha avuto meno e si trova in difficoltà. Essere generosi in vecchiaia è un lusso dell’anima che a volte i giovani non si possono permettere.
Se queste sono le dimensioni che in vecchiaia fanno la differenza, ci sono invece cose che accomunano questa età della vita, ovunque si sia nati o si viva.
Non solo la debolezza del corpo e della mente, diversa per ciascuno, ma per tutti inquietante e gravida di paure, di fatiche, di domande senza risposta. Non solo la fuga della bellezza dal volto e dalle membra. Ma una prospettiva accorciata dell’esistenza.
Progetti? Sì. Ma non a lunghissimo termine. I progetti si spostano da sé ai figli, ai nipoti, al sociale che si ha intorno. Ma è come se l’orizzonte che prima si aveva davanti lo si vedesse ravvicinato. Come se si avesse un ulteriore difetto di vista. E invece è questa la giusta percezione visiva.
La scoperta del mondo che si fa vuoto. Il venir meno di figure care. Non solo la scomparsa del partner, una vera e propria amputazione che prima o poi accade. Ma la scomparsa dei volti che facevano il nostro mondo, che ci hanno accompagnato nei decenni. La scomparsa di una folla di persone. I lutti sempre più numerosi. Il paesaggio umano più rarefatto quasi di giorno in giorno. Le lacrime che pian piano si consumano. Non perché ci si abitua e si diventa più indifferenti. Ma, ecco, si comincia a capire che davvero si resta soli. E che ben presto anche noi faremo parte di quel paesaggio sprofondato nel buio e nell’inconsistenza. I luoghi che ci sono più familiari o più amati faranno a meno di noi. Le generazioni che ci seguono avranno, senza di noi, le loro gioie e i loro dolori. Le loro conquiste e le loro sconfitte. E noi non le conosceremo.

Opera di Andrew Wyeth.
È per far fronte a questo che occorre elaborare un nuovo pensiero dell’umano, in cui ogni istante vissuto, finché c’è coscienza, finché c’è desiderio, finché c’è “crescita” possa trovare uno spazio, una ragion d’essere, una motivazione ad amare la vita. Senza separare, brutalmente e burocraticamente, i vari stadi dell’esistenza.
Ecco che cosa è aver cura. Non solo accudimento, non solo risposta immediata a un bisogno, risoluzione di un problema. Nell’Ermeneutica del soggetto Michel Foucault scriveva: “L’umanità sembra avere l’obbligo di prendersi cura dell’altro, non per scelta etica, ma come atto fondativo della sua essenza”. Ma questo attiene già al vivente nel suo complesso. È molto evidente nel mondo animale, fra poco lo sarà anche nel mondo vegetale. Ma è dell’umano aggiungere a questa dimensione primaria, elementare, qualcosa in più, un oltre, un oltrepassamento di ciò che è puro accudimento. Ci vuole slancio. Ci vuole applicazione dell’intelligenza, applicazione dell’immaginazione, applicazione d’amore che ecceda l’ordinario.
È qui che dovrebbe entrare in gioco anche una passione propositiva della polis. Ma qui si vede anche come l’umano sia imbrigliato dentro una dimensione utilitaristica, funzionale a risposte immediate, senza progetto, senza futuro, senza visioni. È qui che si palesa, in tutta la sua brutale evidenza, la differenza tra la cura e l’incuria.
Ed è qui anche che si spalanca quella sorta di terra di nessuno che è la vecchiaia estrema, o la malattia giunta alla sua fase terminale, o comunque quel tempo che non si può più neppure chiamare tempo, perché è una sorta di sospensione nel vuoto e nell’assenza che ci condurrà inevitabilmente a varcare la soglia. Il tempo in cui la coscienza è silente. Rimane, talvolta, il dolore intollerabile e superfluo, sprazzi di terrore, una sopravvivenza non voluta e non goduta. Qui il discorso si fa difficile e delicato. Ma certo a tutti dovrebbe essere concesso di poter scegliere, finché ancora è possibile, se essere tenuti in “vita” a tutti i costi o se essere accompagnati, dolcemente, umanamente, e sapientemente oltre la “soglia”.
Pensiamo ai vecchi che si trascinano spenti e in solitudine nelle case di riposo, o quelli che rimangono in una abitazione priva di conforti affettivi, dei minuscoli piaceri simili a quelli di cui sanno godere anche i bambini, accuditi in maniera sbrigativa, quando lo sono, privi di lacrime consolate, di ricordi condivisi, con la mente che si spegne perché non si nutre di nulla. Sono i testimoni muti di una vergogna taciuta del nostro modo di essere “civili”. Certo il problema non è di semplice soluzione. Ma occorrerebbe mobilitare forze, inventare nuovi moduli architettonici, nuove forme di integrazioni familiari e comunitarie per impedire che le esistenze umane finiscano in questo modo inumano. Il che non significa prolungare a tutti i costi il numero dei giorni. Anzi. Occorrerebbe imparare anche il distacco, elaborare un accoglimento della fine, sapere che, appunto, siamo destinati anche a finire, non solo a incominciare, e che soprattutto occorrerebbe addestrarsi, come in un esercizio di ascesi, a capire quando è il momento di disserrare le mani e il cuore e lasciarsi andare. “Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore” (Sal 89,12).
Ma appunto, una cultura della cura ci dovrebbe educare ad accompagnare il morente, ad essergli accanto quando “il respiro si fa aria” (per usare una splendida espressione del medico Paul Kalanithi, che ha raccontato fino quasi alla fine la sua lotta con la malattia e poi la decisione di lasciarsi andare, preso però quasi per mano dai suoi affetti più cari). Nello stesso tempo, una cultura della cura non dovrebbe ostinarsi a tenere “in vita” esistenze che finiscono in un dolore senza soluzione e senza guarigione, o che non hanno più non solo coscienza, ma neppure un sentire d’esser vivi, un percepire uno sguardo, o una parola o una mano che accarezza. Appunto, non è il numero di giorni che conta. Ma come e con quale prospettiva questi giorni si vivono. In tutti questi casi aver cura significa lasciar andare, non accanirsi con stolida crudeltà su una esistenza che non esiste più, che non ha più nulla di umano.
La soglia
Ecco, allora, la necessità di guardare in faccia quel “tempo inghiottito dal tempo”, quel “tempo senza tempo” che è la soglia che separa il morente dal vivente. Un evento puntiforme, senza ritorno, “l’ultimo nemico”, come lo chiama la tradizione cristiana, cui però concede una sorta di proroga schiudendo, nell’immagine onirica e incerta della resurrezione. la dimensione di una nuova vita che si rigeneri sulla terra. Si comprende molto bene, del resto, perché le religioni abbiano escogitato innumerevoli vie d’uscite all’impensabile definitività della morte: duplicando il regno dei vivi, promettendo ritorni sulla terra, suggerendo la visione di un mondo di luce e di gloria dove regneranno finalmente la giustizia e il perdono, stabilendo continuità con i propri antenati, raggiungendo gli spiriti dei trapassati, placando la fatica delle continue rinascite in un felice vuoto fatto di nulla. Nessun sorriso di sufficienza è lecito nei confronti di queste esuberanze dell’immaginario. Anche questa è, se vogliamo, “cura” di quella vertigine che ci prende quando pensiamo al “mistero indicibile” del morire. Voler spiegare, voler consolare, voler dare senso a tutto ciò che appartiene alla vita – e dunque anche la morte – è una grande conquista dell’umano.
Bisogna però tener conto che il linguaggio del nostro tempo esige altre narrazioni, altre figure, altre avventure del pensiero, che non necessariamente soppiantano le prime, ma, per così dire, le affiancano, le portano oltre, senza presumere di raggiungere stadi definitivi.
Ma rispetto al più definitivo degli eventi che cosa si può dire che rimanga? Che cosa significa, applicato alla morte, il “prendersi cura”? Quale ne sarà l’oggetto? Quali le modalità, una volta che si sia fatto tutto il possibile per aver cura del morente, accompagnandolo oltre quella porta spalancata che poi si richiude per sempre? Qual è, se non c’è più l’umano, il senso di “cura”? Anche il celebre “Mito di cura” evocato da Heidegger, colloca Cura a fondamento dell’umano, non della sua morte: “L’essere nel mondo ha una struttura conforme all’essere della cura”.
E tuttavia molto ancora c’è da fare intorno alla “morte dei viventi”.
Innanzitutto c’è un raccogliersi intorno alla memoria di chi non c’è più. Anche su questo aspetto ogni civiltà ha elaborato i suoi riti di separazione dal mondo dei vivi e di elaborazione del ricordo di chi non c’è più. La nostra, dominata da una fretta sbrigativa, ha accelerato e in un certo senso svilito ogni pratica di celebrazione funebre. Ma se questo può favorire una deriva verso la dimenticanza di chi non è più con noi, tanto più preziosa rimane la cura della memoria. Tenere a mente un momento vissuto. Trattenere le fattezze di un volto. Ricordare una data. Rielaborare ciò che abbiamo ricevuto. Aver caro un oggetto. Ripercorrere l’itinerario di un’esistenza, per quanto piccola, o nascosta, o insignificante essa sia stata. “Mio padre – scriveva Vladimir Jankélévitch – non è nel cimitero dove è sepolto. È piuttosto al suo tavolo di lavoro e nei libri che mi ha lasciato, nel pensiero che mi ha trasmesso. È in queste cose, non nel cimitero. Nel cimitero non c’è niente”.
È vero che il ricordo dei propri cari non durerà in eterno. Ed è vero che nessuna memoria è in grado di trarre dall’oblio le vite smarrite, le vite che nessuno ha conosciuto, le vite dei senza nome, dei senza volto, dei senza voce. Ma proprio per questo la memoria deve compiere il suo lavoro perché non solo siano custoditi nel ricordo coloro che ci sono cari, ma anche tutti i vinti e dimenticati da noi e dalla storia.
In questo senso è utile ricorrere ancora a Jankélévitch, quando parla della morte come di un “muro opaco”, una sorta di insormontabile barriera, che inevitabilmente ci ribalta indietro verso la vita che abbiamo avuto. “La morte non è il vetro trasparente dell’essere, o la faccia nascosta del nostro destino, ma piuttosto lo specchio che rinvia al nostro quaggiù la sua propria immagine”. Ciò che conta non è tanto il morire, ma come si è vissuti. Perciò la morte, che accompagna tutta la nostra vita, deve indurci a una pienezza di vivere, a un dispendio di sé verso il mondo e verso gli altri, perché ciò che siamo stati, con tutta la nostra debolezza e incompiutezza, sarà il segno che avremo impresso sulla ruvida crosta della terra. Mi piace ricordare, a questo punto, un detto della tradizione rabbinica: “Non sta a te compiere l’opera, ma non sei libero di sottrartene”. Questa è l’ambigua condizione dell’esistenza umana. C’è qualcosa su cui possiamo, limitatamente, avere dominio. Per il resto non rimane che affidarci, cercare, sperare, desiderare.
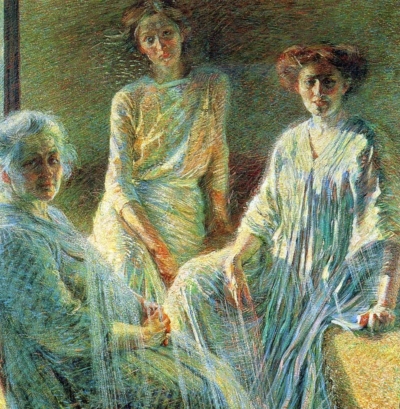
Umberto Boccioni – Tre donne (1909 -1910)
Gabriella Caramore
Qui il link per il secondo incontro.
Se continuiamo a tenere vivo questo spazio è grazie a te. Anche un solo euro per noi significa molto. Torna presto a leggerci e SOSTIENI DOPPIOZERO

Ayasofya: interno,
stampa dei fratelli Fossati
Istanbul: Ayasofya
Doppiozero, 20 agosto 2020
Gabriella Caramore
Riprendo in mano un vecchio libro illustrato, di una cinquantina d’anni fa, dedicato a Santa Sofia (a c. di Lord Kinross, Mondadori, 1992), la basilica prima cristiana, poi cattedrale ortodossa, poi moschea, e ancora dopo museo, ora ridiventata moschea per consolidare le mire nazionalistiche del nuovo “Sultano” Erdogan. Sfoglio il libro e ritrovo il fascino delle pubblicazioni di quegli anni: ricchissima ricerca iconografica, ma senza le alte definizioni ormai in uso; una piccola antologia critica che forse oggi potrebbe essere più esauriente; una ricostruzione storica accurata, ma che tradisce una predilezione spiccata – e dunque perciò stesso datata – per il significato che quel tempio ha rappresentato per la cristianità, a partire dal titolo stesso del libro: Santa Sofia, come se si trattasse di una santa di nome Sofia, e non dello “Spirito di Sapienza” cui la basilica fu dedicata fin dalle sue origini. ….
Istanbul: Ayasofya
Riprendo in mano un vecchio libro illustrato, di una cinquantina d’anni fa, dedicato a Santa Sofia (a c. di Lord Kinross, Mondadori, 1992), la basilica prima cristiana, poi cattedrale ortodossa, poi moschea, e ancora dopo museo, ora ridiventata moschea per consolidare le mire nazionalistiche del nuovo “Sultano” Erdogan. Sfoglio il libro e ritrovo il fascino delle pubblicazioni di quegli anni: ricchissima ricerca iconografica, ma senza le alte definizioni ormai in uso; una piccola antologia critica che forse oggi potrebbe essere più esauriente; una ricostruzione storica accurata, ma che tradisce una predilezione spiccata – e dunque perciò stesso datata – per il significato che quel tempio ha rappresentato per la cristianità, a partire dal titolo stesso del libro: Santa Sofia, come se si trattasse di una santa di nome Sofia, e non dello “Spirito di Sapienza” cui la basilica fu dedicata fin dalle sue origini.
Il fascino, per me, è dovuto anche alle reminiscenze di un viaggio, compiuto in Turchia, verso la metà degli anni Ottanta, un viaggio povero e avventuroso, pieno di pensieri, di sguardo, di bellezza, di conoscenza. Entrammo ad Ayasofya (il nome turco sul calco di quello greco, Aghia Sophia) con un sentimento di ammirazione, quasi di orgoglio, al pensiero che in quel paese – in cui vedevamo convivere un’anima laica e una musulmana – esistesse un luogo così, un po’ come una casa di preghiera e di pensiero per tutti i popoli.

Due architetti svizzeri, Gaspare e Giuseppe Fossati, ricevettero nel 1846 l’incarico dal sultano Abdul Megid di restaurare la moschea. I due fratelli dovettero demolire gli edifici all’esterno per puntellarne le mura.
Ma oggi a riguardare quel libro subisco anche la fascinazione della onesta e minuziosa ricostruzione storica, attraverso riproduzioni di disegni, fotografie, mappe, ingrandimenti, suggestioni diverse di un monumento che ha subito nei secoli devastazioni, saccheggi, incendi, terremoti, crolli, e poi ricostruzioni, ristrutturazioni, reinvestendolo ogni volta di un nuovo significato simbolico. Prima di essere costruito, era già nella mente di Costantino, che vagheggiava per Costantinopoli, la “Seconda Roma”, una “grande chiesa” che fosse vero santuario per tutta la cristianità e dunque per tutto l’impero. La basilica, che fu inaugurata nel 360 dall’imperatore Costanzo II, attingendo alle tecniche della grande architettura imperiale, poco dopo fu distrutta da un incendio; di nuovo ricostruita, di nuovo incendiata, fu poi inaugurata di nuovo nel 537 dall’imperatore Giustiniano. Legni pregiati, marmi, quintali d’oro, il lavoro di migliaia di operai: nulla fu risparmiato per dare grandiosità a quel tempio, che fu però sempre mira di sogni impropri. All’avvento dello scisma tra Oriente e Occidente la chiesa fu convertita in cattedrale ortodossa, sede del Patriarcato di Costantinopoli, poi riconvertita dai soldati della IV crociata in cattedrale cattolica di rito romano, poi ancora sede della Chiesa ortodossa, che ritrovò in quello splendore, in quelle cupole, in quei mosaici, in quelle luci (l’immensa cupola appare leggera per le quaranta finestre di luce che la circondano), l’intelaiatura della sua “teologia della bellezza”.
Ma ecco, la storia di nuovo si accanisce a distruggere, a trasformare, a ricostruire. Alla caduta di Costantinopoli, nel 1453, con l’avvento dell’impero ottomano, il grande baluardo della cristianità si trasforma in moschea. La croce viene sostituita da una mezzaluna, gli splendidi mosaici cristiani vengono oscurati, versetti e scritture coraniche vengono incorniciati ai pilastri e ai fusti delle colonne, i minareti si innalzano a dare una nuova e diversa armonia alla basilica preesistente. Il nome, però, rimane lo stesso: troppo grande era il prestigio che aveva acquistato nei secoli, e in ogni caso la santità della sapienza è un arco di luce dentro il quale ogni religione può risplendere. Ayasofya diventa il simbolo dell’impero ottomano. Fino alla sua disfatta e al suo smembramento, alla sua trasformazione in Repubblica di Turchia, il 24 luglio 1923. Fu il primo presidente, Mustafa Kemal, chiamato poi Atatürk, il “padre dei turchi”, che volle dare al paese un’impronta di laicità, scommise su un suo avvicinamento all’Occidente, ne modificò i costumi, ridimensionò il ruolo delle istituzioni religiose. E trasformò la moschea di Ayasofya in Museo, ripristinando anche i simboli cristiani, in nome di una possibile convivenza tra fedi e culture. Era il primo febbraio 1935.

Urna di alabastro per le abluzioni dei fedeli risalente all’epoca di Giustiniano.
Oggi, di nuovo, la storia impone una svolta. Il 24 luglio – si noti la coincidenza della data, come a voler ricostituire una continuità con il disfatto impero ottomano – il presidente Erdogan, con una manifestazione imponente per numero di partecipanti e per l’ostentata ritualità (Erdogan stesso ha voluto aprire la preghiera leggendo versetti del Corano) il museo cessa di essere tale e diventa luogo di culto islamico.
Certo, le riconversioni dei luoghi di culto sono sempre accadute. Dobbiamo sapere però che sempre sono state accompagnate da gesti violenti, soprusi, espressioni di volontà di potenza. Del resto il nuovo sultano Erdogan, sottraendo la “nuova” moschea al Ministero della cultura e affidandola alla Presidenza degli affari religiosi, si allea ancora più saldamente con l’ala conservatrice e estremista del paese, dando speranza ai sogni di una nuova espansione e un nuovo impero. Inserendosi come un cuneo fastidioso e minaccioso nelle tensioni tra Stati Uniti e Russia, tra Siria e Libia, rivaleggiando con l’Egitto, rialzando la testa sulle coste dell’Egeo, incurante di quello che può scatenare un passo troppo azzardato. È una parte di mondo già in fiamme. Basta un nulla a scatenare la fatidica “seconda” esplosione. E serve a poco affermare, anche se con dolore, che le religioni sono sovente “strumentalizzate” dai poteri politici. Forse occorre cominciare a rendersi conto che le religioni, in quanto fattori di aggregazione, e dunque fortemente identitari, non sono mai state separate da un ruolo anche politico nella storia delle nazioni. A meno che non siano state ridotte a piccoli “resti”, minoranze in grado di custodire le poche parole di sapienza (di “aghia sophia”) consegnate loro dalle lunghe tradizioni.
C’è stato chi ha detto che non c’è niente di male a riconsegnare a luoghi di culto i patrimoni religiosi. Anzi, le opere d’arte è meglio vederle nei luoghi che le hanno per primi ospitate piuttosto che in un museo. Ma non è questo che è in gioco. È in gioco quella che era stata una grande conquista della Turchia di cento anni fa: la possibilità di prescindere da un rispecchiamento identitario per allargare i confini culturali delle patrie.
Per questo il gesto di laicità di Atatürk era un momento di respiro nella lunga catena delle distruzioni. Non perché avesse spento il valore e il senso di quelle eredità. Ma perché le metteva a disposizione del mondo.
E ora? Che cosa resta da fare nei giochi internazionali che si fanno sempre più sinistri e intimidatori? Riuscirà la forza mite della sapienza che unisce i popoli a far fronte allo spirito di sopraffazione?
C’è da dubitarne, ovviamente. Ma esiste un’altra strada?

Gabriella Caramore